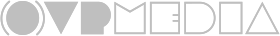Da un paio di anni a questa parte, nel dibattito politico, mediatico e scientifico a livello mondiale, è divenuto virale il neologismo anglosassone “fake news” come indice di un fenomeno che a causa delle caratteristiche della rete, sarebbe latore di una inedita quanto fatale minaccia per la tenuta dei regimi democratici: in sostanza, la disinformazione on-line privando il cittadino di una informazione completa, parziale e oggettiva minerebbe la sua capacità deliberativa in campo politico e dunque la genuinità delle elezioni. Di qui, la richiesta di un intervento dei pubblici poteri volto a reprimere il fenomeno.
La gran parte dei giuristi che si occupa del diritto dell’informazione ha avuto buon gioco nel rilevare il carattere ideologico di questa posizione che è emersa a partire dal 2016 – dopo dieci anni di attività dei social network – a ridosso della elezione di Trump, della Brexit e di altri esiti elettorali avversati quanto imprevisti dal mainstream. Dunque, dopo decenni di dibattiti sulla mancanza di pluralismo informativo, sulle omissioni e le asimmetrie del processo comunicativo, sulle cause della disinformazione nei media tradizionali (simbolicamente rappresentata da quella che è stata definita la madre di tutte le fake news, ossia le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein) si arriva alle inevitabili conseguenze: i media stanno perdendo la capacità di comprendere e di orientare gli elettori.
La reazione, però, è quella di mettere in discussione la libertà di manifestazione del pensiero su cui poggia l’intero edificio democratico. Dunque, pur essendo indirizzata alla rete, la campagna contro le fake news rappresenta forse qualcosa di più pericoloso di «una guerra tra vecchi e nuovi media – e vecchi e nuovi centri di potere – per il controllo dell’opinione pubblica».
Quel che sta cominciando ad inquietare i giornalisti, in primis quelli della carta stampata, infatti, è che per la prima volta nella storia delle democrazie contemporanee, gli attori politici propongono un intervento dei pubblici poteri per punire, censurare (direttamente o indirettamente) – o peggio ancora per certificare con organismi pubblici o privati – il falso informativo in quanto tale: non la diffamazione, la frode, il raggiro, l’aggiotaggio, la violazione della proprietà intellettuale o della fede pubblica, ma il falso in sé e per sé, riferito peraltro non al dato nudo e crudo ma addirittura alle notizie.
Qui non si tratta solo dei falsi artatamente confezionati con le nuove tecniche digitali, come la clonazione di articoli di testate giornalistiche on-line, o come i software (ro)bot in grado di agire sulla rete alla stregua di esseri umani con la creazione di account falsi a fini di propaganda occulta. Né si tratta solo delle affermazioni evidentemente prive di qualsivoglia fondamento scientifico (es. “Il Sole gira intorno alla Terra”). Anche su questo tipo di contenuti, peraltro, si potrebbe obiettare che i falsi digitali hanno le gambe corte, visto che i professionisti dell’informazione sono in grado di smascherarli (magari proprio con l’ausilio delle nuove tecnologie) senza alcun bisogno di interventi normativi. D’altro canto, non può sfuggire che l’utilizzo più o meno occulto dei mezzi di comunicazione per influire sulle vicende politiche di altri Paesi è un fenomeno antico e piuttosto diffuso nel panorama mondiale. Allo stesso modo, per le fantasie in campo medico o scientifico, ci si dovrebbe chiedere: quando l’istruzione e il buon senso non fossero più in grado di salvaguardare la capacità deliberativa dei cittadini in qualsiasi campo, innanzi alla morte della ragione, a cosa gioverebbe la potestà d’imperio, se non a restaurare anche di diritto l’evo oscuro in cui prosperò la cosmologia tolemaica? Il rogo di Giordano Bruno ci scandalizza perché il filosofo aveva ragione o perché l’autorità politica pretendeva di essere depositaria della verità assoluta, giusta o sbagliata che fosse?
Ma, come si diceva, qui non è solo questione di account falsi, di articoli clonati o di fantasie spacciate per verità. Gli interventi pensati o adottati dai pubblici poteri mirano tutti a toccare i contenuti informativi senza definire a monte né l’oggetto della falsità (i dati, gli eventi, la narrazione ragionata degli stessi?) né tantomeno il parametro per affermarla, sul presupposto che sia sempre possibile verificare sul campo la rispondenza al vero oggettivo di qualsivoglia dato o notizia. E, si badi, proprio in questa epoca, caratterizzata da uno stato permanente di guerre e terrorismo a livello globale, associato alla crisi sistemica dei media.
In questi giorni si discute nel Parlamento francese la proposta di legge sulla lotta alle false informazioni durante il periodo elettorale, che prevede sia l’introduzione di un potere di censura amministrativa sul mezzo televisivo nei confronti di contenuti riconducibili alla propaganda di Paesi stranieri, sia il sequestro giurisdizionale d’urgenza nei confronti di notizie on-line asseritamente false. La proposta è stata aspramente criticata dalla principale organizzazione rappresentativa dei giornalisti d’oltralpe. Come si legge nel comunicato stampa diramato dal SNJ (Sindacato Nazionale dei Giornalisti) il 10 marzo scorso, attribuire ad un giudice il potere di rimuovere una notizia entro 48 ore dal ricorso, significa conferirgli il potere di «decidere sulla veridicità di notizie la cui attendibilità richiede talvolta indagini di diversi mesi». Allo stesso tempo questo sistema oltre ad «indebolire la protezione delle fonti giornalistiche», metterebbe in pericolo «l’intera catena dell’informazione». In definitiva, «con il pretesto di combattere la diffusione di notizie false, questo testo minaccia la libertà di espressione e la libertà di informare».
In effetti, il sequestro sarebbe destinato ad intervenire indipendentemente da ogni dubbio relativo alla commissione di un illecito, per giunta sulla scorta di un parametro assolutamente indeterminato (perché il testo parla solo di «informazioni false in grado di influire sulla sincerità del voto»).
Ad analoghi esiti, ma con l’aggravante dell’assenza di un giudice, conduce la legge tedesca del 30 giugno 2017 alla quale si ispirava anche il disegno di legge Zanda sulle fake news che era stato presentato al Senato il 14 dicembre 2017, durante la XVII Legislatura. Qui la censura avrebbe dovuto essere esercitata per interposta persona, imponendo ai social network di rimuovere (entro sette giorni) contenuti «non manifestamente illeciti» ma fatti oggetto da parte degli utenti di un certo numero di segnalazioni a causa della asserita «falsità del loro contenuto».
In Italia, oltre al disegno Zanda, c’è da menzionare il disegno di legge Gambaro presentato anch’esso nella scorsa Legislatura e volto a rinverdire quelle fattispecie di reato che nel Codice Rocco rappresentano il legato più tipico del ventennio: con l’introduzione degli artt. 265-bis e 265-ter, il progetto si proponeva in sostanza di estendere al tempo di pace la punizione del disfattismo politico (reato attualmente previsto solo per il tempo di guerra dall’art. 265 c.p.); con l’art. 656-bis invece si sarebbe creato un altro reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose (già previsto dall’art. 656 c.p.) per estenderlo al web – ad eccezione delle testate giornalistiche on line – senza peraltro inserire nel testo del nuovo articolo la condizione di punibilità (la turbativa dell’ordine pubblico) che ha preservato l’art. 656 del c.p. da una dichiarazione di incostituzionalità. Almeno fino all’ultima volta in cui il giudice delle leggi è stato interrogato sul punto (era il 1976).
Unanime il coro dei giuristi sul citato disegno di legge: violazione dei principi di determinatezza, tassatività e offensività delle fattispecie di reato, connessa alla patente violazione della libertà di manifestazione del pensiero in nome di un sinistro richiamo allo Stato Etico di matrice totalitaria, se non al suo antesignano medioevale fondato sulla negazione del diritto di eresia.
Non meno inquietudine, presso la stampa internazionale, destano gli interventi pubblici apparentemente più morbidi ma tesi comunque a delegittimare e a privare delle necessarie risorse finanziarie l’espressione di opinioni sgradite, sempre facendo leva sul carattere inevitabilmente indeterminato della nozione di falso informativo.
Ciò è reso palese dal recente scandalo suscitato dall’operato della piattaforma on-line europea EUvDisinfo, creata dall’UE per difendersi dalle campagne di propaganda attribuite al Cremlino. Nel gennaio scorso, la piattaforma ha etichettato come falsi informativi tre articoli di tre testate olandesi on-line: gli articoli riportavano le opinioni di un sociologo (apparse anche sul Guardian) che aveva vissuto in Ucraina e che descriveva il Paese come uno Stato oligarchico, senza media indipendenti, onde poi segnalare la crescita dei movimenti fascisti e l’alta considerazione di cui gode l’esercito di resistenza, accusato di aver ucciso migliaia di ebrei durante la II Guerra mondiale. I responsabili della piattaforma – che avevano agito su istanza di un’associazione denominata “Promote Ukraine” – si sono trincerati dietro un errore di traduzione, come se delegittimare apoditticamente una opinione (ossia la frase frutto dell’errore: «L’Ucraina è uno Stato fascista») etichettandola istituzionalmente come “notizia falsa”, possa rappresentare un fatto meno grave.
La questione ha scandalizzato la stampa d’oltreoceano. Emblematico l’articolo a firma di Michael Birnbaum, apparso sul Washington Post del 25 aprile scorso, dal titolo: «L’Europa vuole reprimere le notizie false. Ma ciò che per qualcuno è una notizia falsa, per qualcun’altro è dissenso democratico».
Ciò nonostante, il 26 aprile scorso la Commissione Europea ha annunciato di voler esportare il modello di EUvsDisinfo alla sua politica di contrasto della disinformazione on-line.
Innanzitutto, le piattaforme on-line saranno tenute ad adottare un codice comune di buone pratiche teso, tra le altre cose «a restringere il numero di possibili bersagli di propaganda politica e ridurre il profitto dei vettori di disinformazione». Inoltre, un gruppo di “esperti” reclutati da un centro di ricerca privato (l’International Fact Cheking Network – IFCN, ramo del Poynter Institute), qualificati alla stregua di «verificatori di fatti» agiranno su una apposita piattaforma on-line gestita dall’UE, con la pretesa di insegnare il mestiere ai giornalisti, etichettando come vere o false le informazioni circolanti on-line.
Per avere un’ulteriore riprova del funzionamento di questi sistemi, è sufficiente controllare i due siti italiani di verificatori di fatti già accreditati presso L’IFCN (Pagella Politica e Lavoce.info) all’interno dei quali attori certamente non estranei al dibattito politico etichettano non solo dichiarazioni relative a dati verificabili ma anche analisi di carattere generale aventi ad oggetto lo stato della società e dell’economia italiana. Esempio tipico: L’Italia si sta impoverendo negli ultimi anni? Bufala! Perché esiste una statistica sulla “povertà assoluta” nel biennio tal dei tali che la considera stabile.
Come dice Margaret Sullivan sul Washington Post (15 novembre del 2017) è l’espressione Fake News ad essere fuorviante e pericolosa, e sarebbe ora di metterla in soffitta.
Così mentre la stampa statunitense fa retro marcia, sia pur tardivamente (cioè, da quando il Presidente Trump ha utilizzato l’ideologia delle fake news a suo uso e consumo), da quest’altra parte dell’Atlantico l’UE pensa di imporre a tutte le piattaforme on-line un procedimento direttamente ispirato ai costosi sistemi di assicurazione della qualità delle notizie che Google e Facebook hanno già spontaneamente adottato nel 2017 per consolidare il sostanziale duopolio nel mercato dei servizi on-line, e quindi il dominio nella selezione delle notizie accessibili e sponsorizzabili sul (clear) web. Il sistema è basato sui reclami del consumatore-utente (ossia del soggetto paternalisticamente indicato come vittima predestinata delle fake news) e soprattutto sul referaggio di “esperti” (Facebook si è affidato proprio all’IFCN) che per ora sfocia nella qualificazione di una notizia come “contestata”. La conseguenza di norma non è la rimozione, anche se il 18 aprile scorso Facebook ha bloccato alcuni siti filippini ritenuti latori di fake news. Tuttavia, per la notizia contestata scatta il divieto di sponsorizzazione.
Ed è questa, ancor più dei sequestri, delle censure e delle repressioni penali, l’arma in assoluto più potente per far sparire le notizie urticanti o sgradite che, per definizione, sono quelle più “contestate”.
In effetti, stando alle ricerche più recenti sull’informazione (Julia Cagé, Salvare i media, Bompiani 2016), negli ultimi anni la crisi dei media e della loro credibilità si è acuita a causa della crescita esponenziale dell’influenza del denaro sul lavoro di chi produce le notizie. Tale crescita è dovuta sia all’attuale assetto proprietario dei media (raggruppati in grandi gruppi industriali all’interno dei quali l’informazione non costituisce la prevalente ragione sociale), sia al peso specifico ricoperto nel finanziamento delle testate dagli introiti pubblicitari provenienti da gruppi industriali altrettanto grandi e potenti. Il risultato è la diminuzione del numero delle persone che producono le notizie, rispetto a chi si limita a ri-produrle, e soprattutto, la precarizzazione delle loro condizioni di lavoro – sul piano contrattuale e retributivo – con evidenti ricadute sulla possibilità di esercitare sul campo la professione e anche di resistere alle tradizionali pressioni cui è soggetta l’attività del giornalista.
È solo ponendo mano a questo assetto – secondo la Cajé – che si potrà consentire ai giornalisti di produrre una «informazione accurata, diversa, illuminata», necessaria al libero esercizio dei diritti politici e in grado di riconquistare la fiducia dei cittadini, unico vero strumento di lotta contro le fake news.
Eva Lehner