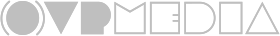Intervista ad Agostino Ferrente, autore del documentario che ha vinto il David di Donatello. Una Napoli lontana dallo stereotipo delle serie tv si racconta in prima persona.
Un film sulle periferie della città partenopea e una scelta controcorrente: puntare su una storia di amicizia tra due ragazzi in cerca di una vita normale, piuttosto che raccontare l’ascesa epica nella criminalità organizzata. Selfie dimostra che la non violenza può essere fotogenica e sensuale
intervista di MARTA RIZZO
Selfie, il film documentario di Agostino Ferrente, per ricordare il 16enne Davide Bifolco, vince il David di Donatello 2020 come Migliore Documentario. Un racconto personalissimo, che ha il potere di scuotere nel profondo ciascuno spettatore e tutti. Davide, ucciso nel Rione Traiano perché scambiato per un latitante da un carabiniere, vive nello spazio e nel tempo filmato in video-selfie dei due sedicenni protagonisti: Alessandro e Pietro. I due amici di Davide abitano a pochi metri dal luogo della tragedia e Ferrente li trasforma in cameraman, dando loro due smartphone, per ottenere un punto di vista “immersivo”, che restituisca e faccia combaciare il loro sguardo e quello della strada, dove i ragazzi del rione trascorrono la maggior parte delle loro giornate. Ale e Pietro sono sempre presenti, protagonisti e testimoni; guidati dal regista, si specchiano nel display del cellulare, filmando e raccontando il loro ricordo. Sullo sfondo, una Napoli popolare e dimenticata, con le sue creature che crescono tra spaccio, sale giochi, carcere, sparatorie e morte; più lontano, uno Stato “latitante” che, quando c’è, spara per “errore” e uccide, di fatto, impunito. Accanto, sopra, affianco a questi diversi livelli di scrittura cinematografica, Ferrente inserisce le testimonianze di altri giovani del quartiere e le immagini delle telecamere di sicurezza poste agli angoli alti di Traiano: impassibili, inerti testimoni di giornate fatte di violenza. La rivoluzione dell’antiviolenza di due adolescenti pieni di malinconia fa il giro del mondo, nel nome di Davide.
Quelle vite raccontate attraverso uno smartphone
Come hanno vissuto questo premio i ragazzi del film?
Con emozione, incredulità e orgoglio. Alessandro l’ha saputo per ultimo, avevo provato a chiamarlo, ma aveva il telefono spento, perché già dormiva con la sveglia puntata alle 5.00 per andare ad aprire il Bar Cocco. Pietro si è commosso, lo ha dedicato a sua nonna con cui aveva girato una scena molto tenera nel film e, poche settimane dopo, è venuta a mancare. Entrambi, naturalmente, hanno pensato a Davide e tutti abbiamo ricordato come, sin dall’inizio di questa avventura, a ogni ostacolo, e ce ne sono stati tantissimi, la famiglia mi incoraggiava rievocando la vittoria di Davide contro Golia. Inevitabilmente, tutti abbiamo sorriso, pensando all’assonanza, casuale ma fatale, tra il nome di Davide e quello del prestigioso premio vinto da tutti: il David di Donatello.
Com’è cambiato il tuo pensiero su Davide, ora che tanti riconoscimenti pubblici, nazionali e internazionali, gli hanno dato quella giustizia che la Giustizia gli aveva tolto?
Come dice con amarezza la famiglia di Davide, il loro bambino è stato ammazzato 3 volte. La prima materialmente; la seconda per come la stampa ha abusato di un pregiudizio sociale, trasformando la vittima in colpevole; la terza quando la sentenza definitiva ha scagionato il carabiniere che aveva premuto il grilletto, condannandolo a una pena di soli 2 anni, sospesa da subito. Un racconto non può far tornare in vita chi non c’è più, ma ho tentato di onorare la sua memoria. Spero che il successo del nostro piccolo film, abbia potuto risanare, almeno in parte, il dolore dovuto a quella che, chi conosceva Davide, considera la sua seconda uccisione: contribuendo a ribaltare, almeno un po’, l’idea che le persone non realmente informate dei fatti, si erano fatte di questo ragazzo e dei tanti come lui. Giovani che hanno la cattiva idea di nascere in rioni popolari dove non avere diritti diventa una colpa. Ale e Pietro, raccontando la loro quotidianità, mostrano al mondo come sarebbe stata quella di Davide, se non l’avessero ucciso.
Cosa ha colpito, secondo te, i giurati David?
Non lo so, immagino che ognuno abbia avuto le sue motivazioni. Molti dei giurati, dopo averlo votato, mi hanno scritto per comunicarmi quello che avevano provato vedendo Selfie. Alcuni mi hanno detto cose somiglianti tra loro, altre molto diverse.
Qual è la rivoluzione di questo tuo film, se c’è?
Ogni opera, non solo cinematografica, dedicata a una vicenda intima, può aspirare a toccare delle corde universali. La tragedia di Davide purtroppo è una delle tante, simili, che accadono ogni giorno nel mondo. Gli abusi del potere e delle forze dell’ordine verso i più indifesi, ovvero verso le persone che dovrebbero invece proteggere, ci sono ovunque: sia nei regimi conclamati che nelle presunte democrazie. E quasi mai il potere processa sé stesso. Probabilmente anche per questo, nella vicenda raccontata da Selfie si sono identificati molti spettatori di ogni Paese: ovunque sia stato presentato mi hanno parlato di un Davide Bifolco del luogo e, per questo, il film l’ho dedicato a tutti i Davide Bifolco e tutti i rioni Traiano del mondo. Dappertutto, per esempio, in questi giorni ci sono iniziative in memoria di George Floyd, l’afroamericano soffocato dal poliziotto bianco che aveva già ucciso in passato, ed era stato già oggetto di varie inchieste. Ciononostante, era ancora in servizio. Anche da noi ci sono tantissime iniziative, di solidarietà e protesta, animate da sentimenti sinceri, senso di ingiustizia e impotenza. Eppure, in Italia, ogni “morte di Stato”, ha seguito lo stesso copione, con tentativi di insabbiamento, disinformazione della stampa (spesso complice) e assoluzione finale dei responsabili. E devo aggiungere che sui fatti italiani non c’è mai stata una simile mobilitazione.
Pensi che i ragazzi di Traiano, ora, avranno un futuro diverso?

Un’inquadratura di “Selfie”
I protagonisti di un documentario hanno la possibilità di rivedersi sullo schermo come se fosse uno specchio, relativizzando la propria vita, ragionando su loro stessi, come se si fosse fatta una lunga seduta di analisi e forse, lo spero, questo può aiutarli. Il problema è che molte questioni non dipendono da loro, ma da chi dovrebbe prendersi cura di loro. Certo, spero che un po’ questa avventura abbia potuto, nel suo piccolo, contribuire a far venire alla luce la povertà educativa, che non riguarda certo solo il Rione Traiano di Napoli. Un film non basta, può dare una scossa, ma non basta. I problemi sono atavici, endemici: il determinismo sociale, il classismo, le disuguaglianze, i pregiudizi, la mancanza di opportunità, di istruzione e lavoro.
Da dove nasce questo film e che film è?
Avevo conosciuto dalla stampa, come molti, la tragedia di Davide. Indagando meglio mi sono imbattuto in un volume dell’Edizioni dell’Asino dal titolo Una città dove ammazzano i ragazzini, nel quale compaiono due racconti di due amici che stimo moltissimo: Maurizio Braucci – lo sceneggiatore di film come Gomorra (2008) e Martin Eden (2019) – e Massimiliano Virgilio, scrittore napoletano brillante e attento. Maurizio aveva collaborato amichevolmente al mio precedente film dal vero realizzato a Napoli (Le cose belle – 2013 co-diretto con Giovanni Piperno, ndr), Massimiliano aveva scritto “cose belle” su Le cose belle… Insomma, mi fido molto del loro sguardo sulla città in cui vivono e che spesso raccontano nelle loro opere e sento di condividere con loro una stessa voglia di comprendere, attraverso l‘arte, invece di giudicare. Il volume spiega in modo chiaro come la situazione delle periferie napoletane sia frutto di un ecosistema di abbandono istituzionale. Come in tantissimi rioni popolari, le famiglie di Traiano mettono al mondo figli con un destino già scritto: se sei figlio, nipote, fratello di qualcuno che ha avuto problemi con la legge, lo sarai anche tu. Questi ragazzi sono dei predestinati. Il film racconta questo e chi cerca di non cadere nella trappola delle tentazioni direi obbligate, come Alessandro, Pietro e Davide, si ritrova ad affrontare una sfida difficile, ma non impossibile. Io faccio film “d’innamoramento”, non film “di denuncia”. Poi, se nei miei film c’è la denuncia, è una conseguenza, non l’obiettivo principale. Dal punto di vista poetico, volevo usare la metafora del come, tra le macerie, possano crescere fiori che resistono anche se nessuno li annaffia. Dal punto di vista sociale (ma i film non devono rubare il lavoro ai sociologi), volevo mostrare come in Italia ci sia ancora un forte classismo legalizzato.
Selfie non è solo un documentario, ma un esperimento di estetica dello strumento cinema e, contemporaneamente, anti-apologia, anti-stigmatizzazione sincera sulla sensualità della non violenza. La retorica dello sguardo che “una certa tendenza del cinema” italiano di denuncia (come scrive François Truffaut sullo stereotipato cinema francese tra gli anni ’50 e i primi anni ’60) sta portando avanti da troppo tempo, viene azzerata, in Selfie. Come hai costruito il film, anche grammaticalmente?
La storia di Davide, lo spunto iniziale, emerge progressivamente, dai racconti degli amici raccolti da Pietro, dalla dolorosa testimonianza raccolta da Alessandro del fratello Tommaso (poi morto anche lui, ndr) e dei genitori del ragazzo; dal sogno di Alessandro in cui la vicenda dell’omicidio dell’amico si incrocia con l’assenza del padre, in un liberatorio e asfissiante bagno al mare. Ma quella morte ha colpito l’intero quartiere, perché quello che è successo a Davide poteva succedere a qualunque altro adolescente. I livelli di sguardo si raddoppiano nei selfie delle dichiarazioni di gruppo fatte dai ragazzini del rione e nel ritorno ritmico e circolare delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Ho tentato di dare uno sguardo antieroico, come dici, affinché lo spettatore potesse partecipare il più possibile a una storia dove buoni e cattivi, giusto e ingiusto, bello e brutto non esistono. Da molti anni cerco di eliminare dal film documentario la figura dell’operatore. Dal mio Film di Mario (1999), girato a Bari, ho l’ossessione di far raccontare le storie dei miei personaggi attraverso il mezzo cinema; fino a Le Cose belle (2013), quando ho dato la telecamera a dei ragazzini per intervistare le loro mamme; la particolarità è che stavolta i ragazzini filmano se stessi e la loro “soggettiva” coincide con l’ “oggettiva”, poiché i due piani si incrociano e si fondono nello specchio del display dello smartphone. Tanto mi sembrava determinante la scelta del dispositivo, che l’ho promossa a titolo del film, pur essendo la parola in sé poco simpatica, ormai associata a un narcisismo debordante. L’intenzione era di far raccontare a Pietro e Alessandro la loro quotidianità anche per far capire come sarebbe stata quella di Davide.
Ti sei battuto contro molti pregiudizi, per realizzare questo film?
Abbastanza. Tutti noi che guardiamo, anche se in buona fede, abbiamo il filtro del pregiudizio, che è uno strumento soprattutto borghese. Quando si è diffusa la notizia dell’uccisione di Davide, la maggior parte della gente, per di più influenzata dalla stampa, ha pensato si trattasse davvero di un camorrista, e, come ricorda Alessandro nel film, ha commentato: “vabbè, uno in meno”. Ma Davide non aveva mai avuto problemi con la legge. E anche se al posto suo ci fosse stato un altro sedicenne con magari qualche conto in sospeso con la giustizia, non andava certo giustiziato seduta stante. A monte, se l’inseguimento della polizia fosse avvenuto in un quartiere bene, tipo il Vomero, il carabiniere non avrebbe sparato, credo io, pensando che quel ragazzino avrebbe potuto essere figlio di un professionista, un medico, un architetto, un avvocato… Ma questi ragazzi che fanno i militari, spesso senza un’adeguata preparazione a gestire le emergenze, sono terrorizzati a loro volta e pensano che sparare sia un modo per prevenire. Il problema non è solo il militare in questione, ma chi lo ha armato e messo lì. In USA Amnesty International (che patrocina Selfie, ndr) spiega il problema dello stigma sociale ai bambini nelle scuole con questo esempio: se vedi un bianco che corre pensi che stia cercando di non perdere il treno o di non arrivare tardi ad un appuntamento; se vedi un nero che corre pensi che stia fuggendo dopo aver commesso un qualche reato.
Alessandro, Pietro, i ragazzi del quartiere intervistati… Chi sono i veri protagonisti di questo film, a parte Davide, presente ovunque, nella sua tragica assenza?
L’espediente di dare ai ragazzi il cellulare li distrae dall’ansia da prestazione di fronte alla telecamera e li fa concentrare su ciò che devono e vogliono dire. Qualcuno equivoca pensando che il mio sia un “documentario partecipato”, ovvero uno film dove il regista consegna la telecamera ad altri che la usano autonomamente, attenendosi a delle linee guida e poi, ricevuto il girato, il regista lo monta. Nel mio caso non c’è mai una delega di regia, neanche parziale: il mio è un documentario “narrativo”, o, come lo chiamano i francesi “di creazione” e io dirigo sempre i protagonisti, che in questo caso sono, ho reso, anche cameraman. Di solito passo molto tempo con loro a telecamere spente, per raggiungere quel grado di confidenza grazie al quale, durante le riprese, non si avverta la mia presenza. E se qualcuno pensa che non c’ero, mi fa un complimento, perché vuol dire che ho raggiunto il mio scopo, dirigere restando invisibile. Certo già aver scelto quei protagonisti, è metà film: ognuno di loro, con la sua storia e faccia, i brufoli, le sue ingenuità e sogni, è portatore di un patrimonio narrativo, poi il mio lavoro di regista consiste nel trasformare le persone in personaggi e fare una sintesi poetica di pochi minuti della loro vita. Amo definirla “drammaturgia della realtà”: creare le situazioni, veicolare i tempi alla base dei dialoghi, ricordare battute utili durante le riprese, ma che magari avevano fatto prima, a telecamera spenta: metterli, insomma, diciamo così, in bella copia… Assumendomi dunque pienamente la responsabilità narrativa, poetica, estetica.
Molto interessante è il tuo approccio con i ragazzi che intervisti nel rione. In particolare, con le ragazze: chi sono quelle adolescenti con smalti psichedelici e occhi trasognati? Come hai fatto a farle sentire a loro agio, mentre le riprendevi?
Come con tutti gli altri, l’idea di chiedere anche a Sara e Antonella di auto-filmarsi è un metodo per placare un po’ l’ansia da prestazione che normalmente assale di fronte a uno strumento di ripresa. Porgendoglielo tra le mani, le ragazze si sono trovate più a loro agio, “padrone” della scena e, dunque, soggetti e non oggetti. E così si son potute aprire maggiormente, concentrandosi su quello che dicevano, dialogando tra loro. E la dichiarazione pubblica di amore eterno ai fidanzatini, che a loro dire rimarrà tale anche nel caso dovessero finire in carcere, è una cosa che considero romantica. Ma è pur sempre una promessa d’amore di ragazzine di 16 anni, perché quando si è innamorati pensiamo e vogliamo che sia per sempre. Magari poi le cose cambiano, e a quell’età cambiano velocemente, quindi non scomodiamo subito l’idea di un assoggettamento cieco e rassegnato a un’arcaica e maschilista cultura dell’appartenenza. Mi spiego: cosa c’è di più importante e valoroso della vita e della libertà? Le ragazze del Rione, s’innamorano di ragazzini della loro età, che, dai 12 anni in su, stanno tutto il giorno sui motorini, nelle sale da gioco, e talvolta finiscono, ancora bambini, in giri più grandi di loro e sanno che o andranno in carcere, o moriranno ammazzati. Così, come loro sembrano pronti a sacrificare la libertà o esistenza, allo stesso modo le fidanzatine, contraccambiano dicendosi pronte a sacrificare la loro libertà sentimentale, promettendogli fedeltà per la vita… Insomma, anche in questo, il determinismo sociale, l’emarginazione, non fanno distinzione tra maschi e femmine: è una fetta cospicua di società viene messa al margine. Il determinismo sociale travalica sessi e ruoli: quelli che finiscono per spacciare stanno a Traiano, quelli che consumano, studenti e professionisti, stanno lì vicino, al Vomero: due mondi che sono due facce della stessa medaglia, che si alimentano a vicenda e si completano. Chi paga, però, sono solamente i ragazzini che spacciano.
Quale differenze hai voluto sottolineare, tra la vita di una periferia del sud, di Napoli, e la vita di spettatori lontani, spesso del tutto inconsapevoli di un mondo quotidianamente al limite tra legalità e illegalità?
La distinzione tra lavoro onesto e disonesto la possiamo fare noi dal di fuori. I ragazzi dei quartieri, come di tante città italiane, ti dicono che se nascono con un padre che spaccia, perché loro non dovrebbero farlo? Come dicevo, la distinzione netta tra bene e male è un concetto molto borghese, teorico: lì ci sono ragazzi che non hanno nessun filtro per distinguere e nella stessa comitiva c’è il ragazzino che ti dice: “Mio padre fa il carrozziere, mio padre il barbiere e mio padre spaccia”. Non sono certo un sindacalista della criminalità, ma guardo ragazzini che stanno 8 ore a spacciare per 80 euro al giorno, senza contributi, tutt’ al più vanno in galera, o muoiono. Di certo i genitori avrebbero preferito un altro lavoro per loro. Ma spesso il “crimine” diventa una conseguenza naturale, non una scelta ponderata e questo meccanismo andrebbe interrotto, cambiando le condizioni che lo provocano. E certo non può farlo un documentario.
Alessandro e Pietro come vivono il loro essere abitanti di Traiano?
Cercando di opporsi ad un destino che sembra essergli stato cucito addosso appena nati. Come dicevo, non è facile, ma neanche impossibile. Loro ci provano, vanno aiutati, supportati, incoraggiati e non guardati con sospetto appena la gente viene a sapere da dove vengono.
Chiudiamo con una cosa bella, oltre il dolore del film. Decidi tu come concludere.
Vorrei ricordare l’Associazione nata in memoria di Davide (Associazione Davide Bifolco Onlus), che si occupa di fare doposcuola volontaristicamente con ragazzi che altrimenti si perderebbero per strada. Di fatto fanno, come possono, quello che dovrebbero fare le istituzioni, che neanche la sostengono. E quando dici istituzione, in posti come il Rione Traiano, subito pensano alle camionette delle forze dell’ordine.