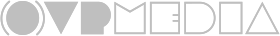Due nuove iniziative online

L’Associazione A mano disarmata prosegue il suo impegno nella diffusione delle culture dell’informazione, della cittadinanza e della legalità con due nuove iniziative sul web
La prima prenderà il via lunedì 10 maggio: “Incontri corsari” è una rubrica periodica nella quale incontreremo protagonisti della cultura, dell’editoria, dell’informazione, dello spettacolo, dell’associazionismo e più in generale dell’attivismo per una cittadinanza democratica attiva e inclusiva. Il primo appuntamento sarà appunto il 10 maggio alle 18 (pagina Facebook e canale YouTube di A mano disarmata) con la presentazione del libro di Giuseppe Cesaro “31 Aprile – Il male non muore mai” edito da La nave di Teseo. A discuterne con l’autore ci saranno Moni Ovadia (artista, scrittore e direttore del Teatro Abbado di Ferrara) ed Alessandro Portelli ( accademico, critico musicale, blogger ed americanista, già professore ordinario di letteratura angloamericana all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
 La seconda vedrà la collaborazione con Giovanni Fasanella, giornalista, scrittore e ricercatore (autore di varie pubblicazioni tra le quali ricordiamo l’ultima “Le menti del doppio Stato” per Chiarelettere Editore). Con lui andremo alla scoperta e alla ricerca di approfondimenti su varie questioni che spaziano dalla storia, spesso quella misteriosa, del nostro Paese a incursioni nei temi d’attualità. Cominceremo il 13 maggio alle 21 in compagnia di due analisti di geopolitica: Michela Mercuri e Germano Dottori. Indagheremo su uno spazio geopolitico, il Mediterraneo, nel quale l’Italia assume un’importanza strategica e che dopo le cosiddette primavere arabe sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti e di lotte sotterranee in cerca di nuovi assetti.
La seconda vedrà la collaborazione con Giovanni Fasanella, giornalista, scrittore e ricercatore (autore di varie pubblicazioni tra le quali ricordiamo l’ultima “Le menti del doppio Stato” per Chiarelettere Editore). Con lui andremo alla scoperta e alla ricerca di approfondimenti su varie questioni che spaziano dalla storia, spesso quella misteriosa, del nostro Paese a incursioni nei temi d’attualità. Cominceremo il 13 maggio alle 21 in compagnia di due analisti di geopolitica: Michela Mercuri e Germano Dottori. Indagheremo su uno spazio geopolitico, il Mediterraneo, nel quale l’Italia assume un’importanza strategica e che dopo le cosiddette primavere arabe sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti e di lotte sotterranee in cerca di nuovi assetti.
Dopo questi primi appuntamenti vi terremo informati sui successivi attraverso questo sito e i canali social dell’Associazione la pagina Facebook ,il Canale YouTube, Twitter (@amanodisarmata) e Instagram (#amanodisarmata)
Secondo appuntamento con le Mappe del Racconto
Sarà un resoconto tutto al femminile quello che martedì 2 marzo dalle 21 alle 23 (pagina Facebook e canale YouTube di A mano disarmata), darà vita alla seconda puntata di “Mappe del racconto – narrare i territori: il Veneto”

Sarà un resoconto tutto al femminile quello che martedì 2 marzo dalle 21 alle 23 (pagina Facebook e canale YouTube di A mano disarmata), darà vita alla seconda puntata di “Mappe del racconto – narrare i territori: il Veneto”, viaggio nell’informazione, nella cultura e nel costume delle regioni italiane organizzato dall’Associazione “A mano disarmata” e dal “Sindacato giornalisti del Veneto”.
La prima puntata (la trovate sulla pagina Facebook di Amd) è stata una sorta di drone che dall’alto ha inquadrato un territorio, quello Veneto appunto, in cui si mescolano inestricabilmente vecchi vizi di uno sviluppo disordinato e rapidissimo, con le nuove frontiere di una criminalità organizzata che qui ha trovato due condizioni necessarie per mimetizzarsi nel tessuto socioeconomico locale: il denaro e la complicità di soggetti in apparenza irreprensibili.
La seconda parte di questo viaggio, si immerge nel territorio attraverso le voci di tre giornaliste, una professoressa universitaria e la presidente dell’Associazione Articolo 21. Un itinerario che segue la rotta che da Ovest arriva all’estremo limite orientale, sconfinando nella zona friulana, dove si sentono gli echi dei Balcani e ci si avvicina a una frontiera carica di Storia.
Così Alessandra Vaccari, giornalista de l’Arena di Verona e consigliera nazionale della Fnsi, sintetizzerà nel suo racconto i cambiamenti strutturali della malavita a Verona. La Bangkok d’Italia della prima metà degli anni ’80 è oggi terra di conquista della ‘ndrangheta, le cui famiglie si sono spartite il territorio. Affari legali si intrecciano a quelli illegali, mentre spunta anche il fenomeno delle baby gang.
Da parte sua Monica Andolfatto, giornalista de Il Gazzettino e segretaria del Sindacato giornalisti del Veneto, ci porterà a Venezia, questa volta sullo sfondo non ci sarà il Canal Grande o la Basilica di San Marco, ma un giro di soldi facili e sporchi, tracce di sangue, tra usura e mazzette. Il tutto attraverso ritratti di donne: Paola la magistrata, Gaetana la commessa, Lucia la regista, Claudia la segretaria:
Mariangela Gritta Grainer, professoressa di matematica, ex parlamentare e Presidente di Articolo 21 Veneto, da anni segue le dolorose e intricate vicende che ruotano attorno all’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994 in Somalia. Un caso che, oltre a segnalare l’eterna difficoltà in questo Paese di arrivare a coniugare Verità e Giustizia, fa emergere il nebuloso rapporto tra Informazione, comunicazione e politica, anche nel Veneto.
Troverà spazio anche un tema, quello della situazione carceraria nella regione, che fatica a fare capolino nell’informazione, se si eccettuano casi eccezionali come rivolte o altri fenomeni violenti. Farà il punto della situazione Francesca Vianello, professoressa associata di Sociologia del diritto e della devianza presso l’Università di Padova, nonché referente per il Polo universitario presso la Casa di reclusione di Padova.
Arrivati a oriente troveremo Luana De Francisco, giornalista de Il Messaggero Veneto, che partendo dalla storia di Fabio Gaiatto, un promotore finanziario di Portogruaro, ci aiuterà a comprendere come la Camorra si sia infiltrata nel circuito finanziario locale. Da Eraclea a Lignano e, più in generale, al litorale del Veneto orientale, e poi su fino alla montagna friulana e avanti fino ai due confini con l’Austria e la Slovenia.
Un corso per imparare a raccontare la verità
Un corso di alta formazione che nasce dalla collaborazione fra Università di Padova, Fnsi, Sindacato Giornalisti del Veneto e Articolo 21. Iscrizioni fino al 1° marzo QUI BANDO E ISTRUZIONI
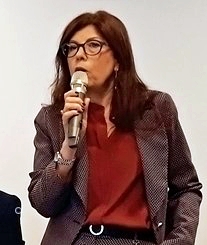
Monica Andolfatto segretaria Sgv
«Giuro di dire la verità, nient’altro che la verità» recita la nota formula delle deposizioni di fronte a un tribunale. Un impegno che dovrebbe essere tatuato nella coscienza di chi, per professione, deve raccontare a un pubblico fatti di interesse generale: il giornalista. Ai condizionamenti che da sempre tentano di deviare da questo imperativo etico i professionisti dell’informazione, si è aggiunta oggi l’estrema complessità di quello che si è andato configurando come un vero e proprio ecosistema informativo, con un intreccio di piattaforme comunicative, un proliferare di media telematici e una potenziale platea che corrisponde ormai al mondo stesso.
Da questo discende la necessità di dotarsi di strumenti adeguati, di mantenersi costantemente aggiornati, di accrescere conoscenze diversificate che spaziano dalla psicologia alla tecnica, dall’economia al diritto, dalla sociologia alle scienze esatte. Era fatale che lungo questo cammino di ricerca e innovazione si incontrassero due istituzioni come il Sindacato dei giornalisti e l’Università.
“Raccontare la verità – Come informare promuovendo una società inclusiva e combattere le fake news”, corso di alta formazione dell’Ateneo di Padova, nasce infatti dal connubio fra l’Associazione territoriale dei giornalisti del Veneto (Sgv) e l’Università patavina, adottando un taglio che individua nella lotta alle false notizie non soltanto uno strumento di riappropriazione del valore sociale dell’informazione, ma anche un mezzo per favorire l’inclusione, ovvero la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.

La professoressa Laura Nota direttrice del corso
Lo chiarisce bene la direttrice del corso, professoressa Laura Nota (ordinaria del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata all’Università di Padova): ««La realtà è complessa – spiega – e non può essere semplificata da una visione parziale o da un approccio stereotipato o peggio ingabbiato da pregiudizi o manipolato da “bufale”. Serve il pensiero critico che va costruito con l’analisi, lo studio, l’impegno, il confronto e l’ascolto».
Le fake news non sono soltanto un attentato alla credibilità dei professionisti dell’informazione e di conseguenza uno dei motivi della loro “decadenza sociale”, incidono direttamente sugli equilibri sociali alterandoli, al punto che la professoressa Nota può affermare che: ««Le fake news sono una delle principali cinghie di trasmissione delle diseguaglianze e fra i temi più caldi della nostra società».

Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Stampa
«È un corso per coloro a cui sta a cuore l’articolo 21 della Costituzione – aggiunge Giuseppe Giulietti presidente della Fnsi – il diritto di essere informati e il dovere di informare in maniera corretta, accurata, verificata».
Organizzato da Unipd con Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana), Sgv (Sindacato giornalisti Veneto) e Associazione Articolo 21, il corso, rivolto ai giornalisti e a quanti a vario titolo operano nella comunicazione, si articolerà in dieci lezioni, tutte on line, per 60 ore complessive dal 10 aprile e fine ottobre: ogni 15 giorni in gran parte al sabato mattina e qualche venerdì pomeriggio.
Le lezioni sono state organizzate in maniera da favorire lo scambio, il dialogo, l’interazione fra i docenti – sia giornalisti di esperienza, che professori universitari di facoltà umanistiche e scientifiche – per stimolare la riflessione e l’apprendimento attivo. Al termine del percorso, all’interno del quale ci saranno anche esercitazioni pratiche e giornate di approfondimento su tematiche di attualità come la divulgazione scientifica e l’infodemia da Covid – verrà rilasciato un attestato universitario.
Queste le tappe programmate:
- L’ecosistema socio-economico e mediatico complesso e frammentato e il pensiero critico quale antidoto
- L’industria editoriale, la disintermediazione, le discriminazioni, l’informazione e la comunicazione
- L’innovazione tecnologica e i social media: ricadute in termini di caos informativo; la responsabilità della Rete, moltiplicazione dei mezzi non significa pluralismo informativo e accessibilità consapevole; linguaggio della discriminazione e dell’odio
- Costruire contesti inclusivi, improntati a giustizia sociale e sostenibilità: cosa vuol dire inclusione, cos’è la giustizia sociale, ruolo dei diritti umani, come questi elementi si intersecano con le azioni giornalistiche; cosa sono gli stereotipi e come si formano, come si contrastano
- Linguaggio inclusivo, attento alla parità di genere, e come controllare attendibilità e validità nei processi di raccolta delle informazioni; come riconoscere e fronteggiare forme linguistiche aggressive e svalutanti anche a vantaggio di un ruolo educativo dell’attività giornalistica
- Tecnologie, piattaforme digitali, accessibilità e innovazione sociale nel settore giornalistico a vantaggio della qualità, la costruzione degli algoritmi nell’informazione, oltre il fact-checking
- Il giornalismo di inchiesta sociale tra oscurità e querele bavaglio, come riconoscere e fronteggiare la fabbrica del falso che inquina le democrazie, l’informazione scientifica e il proliferare delle superstizioni della pseudoscienza
- La deontologia professionale come assunzione di responsabilità civile, la libertà di stampa in Europa e nel mondo tra “editti bulgari”, le carte dei giornalisti, i diritti dei giornalisti a partire dal contratto di lavoro
Affrettatevi quindi, le iscrizioni chiudono il 1° marzo prossimo
Periferie al centro
Perché secondo il regista Mimmo Calopresti è necessario trattare il tema dei margini al cinema
Portare i margini al centro del cinema e al centro della scuola. La rassegna cinematografica L’ombra nera dei margini. Periferie urbane e sociali nel cinema ha permesso alle scuole che vi hanno aderito di mettere a disposizione dei ragazzi le migliori pellicole sul tema e di confrontarsi con gli esperti. Tra questi, il regista, sceneggiatore e attore Mimmo Calopresti, che ha diretto – tra le altre cose – Aspromonte-La terra degli ultimi, La seconda volta, La felicità non costa niente, L’abbuffata. Oggi lo chiamiamo in veste di consulente ed esperto:
Mettere al centro le periferie attraverso il cinema. Perché si è scelto questo strumento?
Il cinema è capace di creare immagini che restano impresse, quindi è perfetto per arrivare a tutti, an- che e soprattutto ai ragazzi. L’Ombra Nera dei Margini però, si pone un ulteriore obiettivo: quello di confrontarsi con gli adolescenti, di capire più e meglio quello che succede nelle loro vite e i problemi che li affliggono, soprattutto quando vivono in periferia, dove le difficoltà sono spesso troppe ma non impediscono ai giovani di voler cambiare il mondo.
Nei dibattiti con gli studenti, cosa ti ha colpito? Come recepiscono i grandi film d’autore che avete proposto?
C’è stata una grandissima partecipazione e penso che l’interesse nei confronti di questo tipo di cinema sia aumenta- to in loro. Il mio compito è quello di aiutarli a fare qualcosa di loro, raccontando i film dal punto di vista registico. Cerco di trasmettere ai ragazzi il coraggio di scegliere e guardare il mondo e la prima regola è imparare a guardare e a raccontare. Guardare non è facile: sembra una cosa scontata ma non lo è, così come anche leggere le immagini. Siamo continuamente bombardati da un’infinità di immagini ma bisogna educare i ragazzi a fare una selezione.
Il mondo del cinema, ma in generale il mondo dello spettacolo, sta vivendo un momento davvero drammatico ma allo stesso tempo lo streaming ci sta venendo in aiuto. Come fare per trovare un giusto equilibrio nel binomio streaming-sala cinematografica per il futuro?
Siamo nel pieno di una grande rivoluzione, la quale è stata accelerata da questo momento tragico che stiamo vivendo: è venuto a mancare il vecchio modo di guardare il cinema e se ne è affermato uno nuovo. Da una parte è negativo perdere l’abitudine di andare in sala e condividere un tipo di socialità, ma dall’altra abbiamo uno strumento in più a nostra disposizione. Dobbiamo imparare a far dialogare questi due mondi, a renderli funzionali alla vita delle persone.

Le recensioni dei ragazzi che hanno assistito alle proiezioni della rassegna cinematografica “L’ombra nera dei margini. Periferie urbane e sociali nel cinema”
ACCATTONE
Che emozioni ti ha suscitato?
Leonardo Grippo: Un senso di grettezza e materialità da parte dei personaggi, un’umanità meschina e allo sbando, che campa alla giornata vivendo di espedienti e furti.
Ludovica Giovinazzo: Divertimento, rabbia e consapevolezza: divertimento per le battute utilizzate; rabbia e consapevolezza per come venivano e vengono trattate tutt’o- ra le donne. Ho apprezzato molto il linguaggio utilizzato e il fatto che la proiezione fosse in bianco e nero.
CIDADE DE DEUS
Che insegnamento ti ha lasciato?
Leonardo Marinelli: Il senso del riscatto: è bello vedere che anche i ragazzi che crescono in contesti difficili possono realizzare i propri sogni. È un film crudo e violento ma necessario.
Francesco Nardi: La prima cosa che mi è venuta in mente è che, ragazzi normali che vogliono vivere una vita in maniera “legale” a volte vengono costretti dal luogo e dalla gente che li circonda a vivere una vita “illegale”. Questa storia è narrata in modo da farti entrare il più possibile nella mentalità dei personaggi, e capire perché fanno queste cose.
FAVOLACCE
Come ti sei relazionato con la complessità di questo film?
Emma Vitale: Sono abbastanza perplessa, ho faticato a comprendere trama e significato, soprattutto per la composizione delle scene. Ho apprezzato molto il fatto che di sottofondo ci fosse sempre qualcuno che leggesse il diario: mi ha aiutato a comprendere alcune scene.
Tommaso Di Pierro: Al di là della trama, sono rimasto impressiona- to dalla capacità dei registi di trasformarsi in attenti scrutatori del contemporaneo, del margine oscuro della società attuale da cui sono pronti a scaturire orrori nascosti in ogni momento, ma non così nasco- sti da non parlare al nostro presente di bambini, figli, genitori, interrogandoci sulle nostre responsabilità, non solo sociali, ma anche affettive di comuni esseri umani.
IL DIARIO DI CARMELA
Ti sei identificato nei personaggi?
Nicolas Tarantino: In un certo senso mi identifico in Carmela perché nonostante il destino segnato, rifiuta la realtà che la circonda e riesce a studiare e ad aumentare il suo livello culturale.
Nicole Camplone: In Carmela perché, nonostante le difficoltà, riesce a fuggire dalla dura realtà che vive ogni giorno creando un diario tutto suo. In questo posso dire di identificarmi in lei perché nonostante le avversità cerca un qualcosa su cui far leva e rialzarsi ogni volta che la vita la butta giù.
Il Veneto fra cronaca e racconto
Il 23 febbraio e il 2 marzo due incontri online con giornalisti, scrittori, magistrati, associazioni e ricercatori
Pagina Facebook e canale YouTube di A Mano Disarmata.
Gli eventi sono validi per 4 Crediti Formativi (2 a incontro)
per iscriversi Piattaforma Sigef all’indirizzo http://bit.ly/lemappedelracconto
Un invito al viaggio (virtuale) nei territori del nostro Paese, per osservare come cambiano l’informazione, i processi democratici, la convivenza civile e quali sono le minacce e i pericoli palesi o nascosti. In questi tempi di fermo per pandemia, l’Associazione “A mano disarmata” vi porta alla scoperta delle regioni italiane: si comincia con il Veneto.
Le varie forme del racconto sono al centro di questa esplorazione: come vengono narrati questi luoghi? C’è un racconto romanzesco, uno cinematografico, uno seriale, uno giornalistico, uno social, ma ci sono anche gli studi, le indagini e le sentenze della magistratura. Attraverso alcuni di questi cercheremo di aggiornare il profilo delle regioni italiane, senza la presunzione di esaurire le questioni, ma con un’attenzione particolare ai temi della libertà di informazione, della partecipazione dei cittadini, dell’ombra minacciosa della criminalità organizzata che da anni ormai ha esteso la sua penetrazione in tutte le aree del Paese.
Grazie alla collaborazione con Il Sindacato Giornalisti regionale le luci dei primi due incontri saranno puntate sul Veneto. Regione conosciuta per le sue bellezze naturali e artistiche (è sede di ben 8 siti patrimonio dell’Unesco) ma anche segmento fondamentale nel panorama economico (con Lombardia ed Emilia-Romagna produce oltre il 40% del Pil nazionale).
PRIMO INCONTRO 23 FEBBRAIO ORE 21
Lo scrittore padovano Massimo Carlotto, autore della saga de “L’Alligatore” (recentemente diventata una serie televisiva su Ra2); il regista Daniele Vicari, da sempre attento al racconto della cronaca in forma di film; il Presidente della Fnsi Giuseppe Gulietti che tra l’altro ha una lunga esperienza di giornalista alla sede Rai di Venezia; il direttore del Centro di documentazione e inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto Gianni Belloni; e il Sostituto Procuratore di Venezia Roberto Terzo, autore di molte inchieste sulle mafie del Nordest. Attraverso i loro interventi cercheremo di fotografare il volto attuale della regione.
SECONDO INCONTRO 2 MARZO ORE 21
La segretaria del Sindacato Giornalisti del Veneto, nonché redattrice de “Il Gazzettino” Monica Andolfatto; la giornalista de “L’Arena” di Verona e consigliere nazionale della Fnsi Alessandra Vaccari; la redattrice de “Il Messaggero Veneto” Luana Di Francisco, autrice di vari saggi sulle mafie a Nordest; la presidente regionale di Art. 21 Mariangela Gritta-Grainer; la direttrice del Master inter-ateneo in Criminologia critica e sicurezza sociale dell’Università di Padova Francesca Vianello. In un incontro tutto al femminile affronteremo la realtà delle varie zone del Veneto attraverso la cronaca., la ricerca e le battaglie per i diritti.
ANAC: il cinema è comunità
DI MARTA RIZZO
Eletti i nuovi organismi dirigenti dell’Associazione Nazionale Autori Cinematografici. Dacia Maraini: «Il buon cinema resiste e riesce a procurare emozioni estetiche ed etiche» – Mimmo Calopresti: «Sono centinaia le famiglie di chi lavora nel cinema a causa della pandemia, sono in gravissima difficoltà economica. L’ANAC si occuperà anche di loro»

Sul finire del 2020 (il 28 dicembre), il cinema ha compiuto gli anni: 125, portati con continui adattamenti alle mutazioni del tempo, tenendo sempre presente che questa è l’unica arte in cui la peculiarità del regista ha ragion d’essere solamente se viene condivisa con decine di persone che lavorano con lui, prima che con gli spettatori. E sul finire del 2020, tra i più memorabili e silenziosi della Storia contemporanea, in Italia, sembra tornare viva un’associazione che, dal 1952, cerca di tenere uniti gli autori di questo unico meccanismo di combinazione tra arte, tecnica, industria e politica che è il cinema. L’Associazione Nazionale Autori Cinematografici (ANAC), in questi giorni di festa del cinema, diffonde la notizia interessante del rinnovo degli organi associativi, avvenuto su piattaforma, tutti collegati dalle proprie case: Dacia Maraini, Pupi Avati, Ricky Tognazzi ed Ezio Alovisi vengono eletti Probi Viri; entrano nel Consiglio Esecutivo Mimmo Calopresti, Giuseppe Gaudino, Giovanna Gagliardo, Emanuela Piovano (nominata anche vice presidente ANAC), Giuliana Gamba, Umberto Marino, Giacomo Scarpelli, Caterina Taricano. Quello che stupisce qui, non è solamente il valore autoriale di chi ha aderito, ma l’adesione in sé. Che accade, in questo impietoso 2020? Si è, forse, risvegliato, in questo vuoto imposto dal virus, una nuova esigenza di appartenenza, di condivisione, di comunità, nella società e tra gli autori? Una forma di ritorno alla Storia degli autori del cinema italiano, per progredire in nome di un passato comune e condiviso? Lo chiediamo a Dacia Maraini e Mimmo Calopresti.

“Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica (1948)
La storia dell’ANAC.
L’Associazione degli autori di cinema nasce nel 1952, dopo lo scioglimento della precedente Associazione Culturale Cinematografica Italiana (nata nel 1944), che univa autori cinematografici, critici e uomini di cultura ed era presieduta da Cesare Zavattini. L’ANAC nasceva da un gruppo di autori tra i quali Age, Alessandro Blasetti, Mario Camerini, Furio Scarpelli, Cesare Zavattini. Dell’ANAC potevano far parte registi e sceneggiatori cinematografici. Le finalità comprendevano obiettivi culturali e politici, tutti legati da un principio comune: la libertà di espressione.
In quel 1952, il cinema italiano aveva fatto i conti con la privazione di tutte le forme di espressione imposta dal Fascismo e, finalmente, portava agli occhi del pubblico una realtà sconosciuta: veniva liberato dalle censure del regime il film Ossessione, che Luchino Visconti aveva realizzato in pieno Fascismo, nel 1942, suo esordio. Da questo film, esplodeva uno dei fenomeni più straordinari della storia del cinema: combinazione tra dovere di raccontare, tensione morale, esigenza narrativa personale e necessità di condivisione e ribellione, il Neorealismo si spalancava agli occhi degli spettatori italiani e internazionali con Roma città aperta (1945), Paisà (1946), Germania anno zero (1947), titoli tra i più emblematici della rinascita dell’Italia, attraverso il cinema. Nel suo oltre mezzo secolo di vita, l’ANAC ha agito intrecciando esigenze ispirate agli interessi diretti, materiali e morali, degli autori e quelle dettate dagli interessi più generali di tutta la cultura italiana. La prima contestazione alla Biennale di Venezia è del 1960. Subito dopo iniziano gli interventi decisivi contro la formulazione della nuova legge sulla cinematografia: i vertici dell’ANAC, il cui presidente era all’epoca Damiano Damiani, misero in crisi il primo governo Moro. Negli anni della protesta studentesca, tra il 1968 e il 1970, l’ANAC (con presidenti come Ugo Gregoretti, Marco Ferreri, Pier Paolo Pasolini e Gillo Pontecorvo), crea un ampio fronte di trentuno associazioni culturali e professionali: da Magistratura Democratica all’ARCI, dalla Psichiatria Democratica di Basaglia alla nuova e insperata adesione di Cgil Cisl e Uil. Le politiche dell’ANAC si riveleranno determinanti negli anni immediatamente successivi, quando la riforma della RAI diverrà una necessità. Nel 1976, con la nascita delle prime emittenti televisive private, i film potranno essere trasmessi sui teleschermi, senza vincoli. Per il Cinema italiano questa diffusione incontrollata di film segnò l’inizio di una crisi. L’offerta cinematografica nelle sale passa, in pochi anni, dal quattromila a settecento trenta sale (1985).

“La dolce vita” di Federico Fellini (1960)
Da allora, ecco alcuni punti base delle rivendicazioni politiche dell’ANAC, nei confronti dei futuri governi, a favore del Cinema italiano: garantire la libertà di espressione, realizzazione e diffusione delle opere e la libertà di scelta degli spettatori; modificare il sistema cinematografico organizzato in funzione del massimo profitto e caratterizzato dalla concentrazione delle sale che impedisce la libera circolazione delle opere, nonché dal monopolio del noleggio con la sua rigida selezione e programmazione della produzione che impedisce il libero confronto delle tendenze artistiche e culturali; la necessità di una legge antitrust in grado di limitare la proprietà, la gestione e la programmazione delle sale.
Intanto, la produzione dei film andava diminuendo di anno in anno, tanto che dai trecento film degli anni Cinquanta e Sessanta, si passò, a metà anni Ottanta, a meno di cento film, quasi tutti prodotti senza autonomia e quasi tutti con aliquote di finanziamenti RAI. Gli interventi dell’ANAC si rivelarono di nuovo indispensabili. Con la Vertenza Cultura l’ANAC, nel 1983, insiste con forza sulla necessità di una radicale riforma del sistema audiovisivo e intraprende azioni che, nel 1987, portano a una svolta della politica cinematografica. Gli inizi degli anni Ottanta furono decisivi, per l’ANAC, anche in campo internazionale. Con la presidenza di Francesco Maselli, insieme a un gruppo ristretto di associazioni di autori europei, l’ANAC promuove la fondazione della Fédération Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel (FERA), con sede a Bruxelles. I primi incontri erano iniziati fin dal 1976 (Italia e Francia, Germania, Ungheria), ma presto il numero divenne più consistente. All’incontro di St. Etienne del gennaio 1980, si aggiunsero Gran Bretagna, Belgio, Grecia e Spagna. Nello stesso anno gli incontri seguirono a Venezia. Successivamente, l’ANAC realizza un’alleanza imprevedibile con la storica associazione dei produttori (l’ANICA), di cui era presidente Franco Cristaldi. La vecchia politica degli imprenditori cinematografici viene ribaltata a vantaggio di una alleanza con la linea degli autori, basata sulla qualità e su un sostegno finanziario ai film per farli nascere indipendentemente dai contributi delle emittenti televisive. La nuova legge, voluta dall’alleanza tra autori e produttori, porta la data del 1994. La produzione di film viene rilanciata, ma non viene eliminato del tutto il vincolo del Cinema alle reti televisive e alle loro logiche. Negli anni che seguono, l’ANAC rinnova il proprio statuto, per renderlo più adeguato ai nuovi tempi di un cinema e di una cultura in rapida evoluzione. È il momento in cui alcuni soci autorevoli vanno a formare una nuova associazione che unisce in sé autori e produttori, come era già avvenuto in Francia: l’API (Autori Produttori Italiani). Alla presidenza di Maselli, succede quella di Carlo Lizzani, fino a Ugo Gregoretti. Uno dei nodi determinanti delle battaglie dell’ANAC resta la difesa e il rilancio dei Diritti Morali e Materiali degli autori, insieme al riconoscimento del diritto alla libertà di creazione. Una lotta per la quale l’appoggio e il sostegno della FERA sono stati fondamentali. Tra le importanti iniziative dell’ANAC, in campo nazionale e internazionale, ricordiamo la nascita della Coalizione Italiana per la Diversità Culturale del 2009, promossa dall’ANAC in collaborazione con la SIAE (Società Italiana Autori Editori), l’Accademia di Santa Cecilia, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Parlano Dacia Maraini e Mimmo Calopresti

Pier Paolo Pasolini, al centro, fu presidente dell’ANAC
Libertà di espressione, difesa dei doveri e dei diritti morali e realizzativi degli autori, tutelare la natura di ciascun autore per tutelare quella di tutti, usufruire delle trasformazioni e dei progressi tecnologici come le piattaforme, ma privilegiare su tutto il luogo consacrato alla collettiva visione buia e silenziosa del film nelle sale cinematografiche. Questi sembrano essere, quindi, i nuovi e i vecchi principi fondamentali dell’ANAC.
Con la morte di alcuni grandi soci e ispiratori dell’associazione, da Pontecorvo a Lizzani, da Scola a Gregoretti, l’ANAC degli ultimi anni sembrava smarrita, di fronte a esigenze di mercato sempre più pressanti e a padri eccellenti che non potevano più segnare nuove rotte, se non tramite la memoria. Da quelle memorie di quel cinema italiano, però, il presidente Francesco Martinotti, assieme a chi nell’ANAC ha sempre visto un collante tra la società e la cultura, sono riusciti a motivare e coinvolgere altri autori: alcuni nomi inaspettati, altri anarchici a tal punto da sembrare imprendibili, altri ancora talmente saggi e consapevoli della necessità di difendere il «nome dell’autore», come diceva Michel Foucault, da sembrare quasi estremi.
Dacia Maraini, la sceneggiatrice, scrittrice e giornalista che tutti conoscono come esempio di autorialità indiscutibile, e Mimmo Calopresti, autore tra i più autonomi, internazionali e allo stesso tempo profondamente legati all’Italia e al suo Sud, raccontano perché hanno deciso di entrare in una coalizione, laddove il virus dovrebbe, a rigore di logica, tenere tutti più distanti.
DACIA MARAINI
 Cosa l’ha spinta ad accettare di entrare nel Consiglio dei Probi Viri dell’ANAC?
Cosa l’ha spinta ad accettare di entrare nel Consiglio dei Probi Viri dell’ANAC?
«Penso che in questo momento di frammentazione e dispersione dei talenti ci sia bisogno di un luogo e uno spazio in cui ci si riconosca e si creino alleanze vitali fra le varie arti: narrativa, cinema, teatro, poesia, musica non sono mondi lontani e separati, ma fanno parte del comune linguaggio di crescita e di consapevolezza di un paese».
In questo tempo impaurito si può ridefinire il concetto di comunità, di appartenenza a un gruppo, per condividere e portare avanti politiche e ideali comuni?
«Certo che è possibile, anche se la paura tende a frammentare i rapporti e ad allontanare le persone le une dalle altre. Ma c’è chi resiste e chi sa che mantenere rapporti, anche se per il momento solo via remoto, è importantissimo…».
Come è cambiato il mondo autoriale italiano degli anni Sessanta e Settanta? È ancora possibile, utile, sensato fare un parallelo, più che un paragone, con quell’epoca che, indubbiamente, ha cresciuto intellettuali di altissimo spessore, come forse non è più successo da allora?
«Non si tratta di nostalgia senza soluzione, ma di ammissione e consapevolezza del fatto che una certa politica e, quindi, una certa cultura, si siano trasformate, col tempo. La differenza sta tutta nella progettualità e nelle idee condivise. Quando una collettività si proietta verso il futuro con fiducia e voglia di cambiare, nasce l’entusiasmo e l’impegno. Oggi viviamo in un tempo di delusione e di isolamento, di personalismi e lotte furibonde per il potere. Gli artisti testimoniano del proprio tempo».

“Marianna Ucria” di Roberto Faenza (1997)
Quali sono i tratti comuni, oggi, tra gli autori italiani?
«Ci sono due atteggiamenti: uno legato alla cronaca e all’attualità che riguarda soprattutto i cineasti impegnati che si interrogano sul che fare, che si concentrano sul reale e lo incalzano. L’altro più a lungo termine si dedica all’approfondimento dei rapporti privati, soprattutto in famiglia. Non c’è dubbio che la famiglia stia cambiando e gli autori cercano di capire come».
Da quasi un trentennio gli autori sembrano aver privilegiato un atteggiamento individualistico, chiuso, asettico, con una forma di diffidenza e autoreferenzialità poco adatte alla crescita, alla diffusione delle idee e delle aspirazioni. Pensa che la pandemia e il diffuso senso di smarrimento, di compassione (patire insieme) che porta con sé, stia facendo tornare la voglia di condividere, di confrontarsi, di mettersi in gioco da parte degli autori?
«In quello che descrivi c’è del vero, ma se andiamo a vedere, nome per nome, film per film, ci accorgiamo che il panorama è diversificato, complesso e vario. Gli autori veri cercano sempre il sommerso e l’invisibile, per raccontarlo a modo loro. E se sono sinceri e poetici, riescono a comunicarlo. Come hai detto giustamente il lungo periodo berlusconiano non ha incoraggiato una atmosfera creativa. Abbiamo vissuto in una società di mercato in cui contava soprattutto la produzione anziché la creazione e questo ha provocato molti danni. Ma il buon cinema resiste e riesce a procurare emozioni estetiche ed etiche».
C’è ancora la possibilità di guardare alla crescita della cultura e delle idee, al servizio della comunità e con i piedi piantati nella Storia del Paese, con fiducia e lungimiranza, a prescindere dai mezzi tecnologici e dalle forme di distribuzione con i quali le stesse idee vengono trasmesse ai cittadini?
«Come ho già detto, la cultura è stata frammentata, e oggi risentiamo della perdita di grandi progetti condivisi che accomunano una collettività. Ma, pur nel disastro della perversa prevalenza dell’io sul noi, un atteggiamento di resistenza e di speranza resiste e credo che i migliori registi di oggi lo esprimano, anche se con dolore e stupore. Non dobbiamo cedere al desiderio di autodistruzione che prende chi vede solo rovina e deserto intorno a sé».
Quali sono i passi principali che l’ANAC, come comunità per la comunità, dovrebbe fare?
«L’ANAC dovrebbe cercare di ricreare un sentimento di solidarietà professionale, una voglia comune di costruire un futuro nuovo, coraggioso, in cui tutti si possano riconoscere. Non soltanto rappresentare la voglia di buttare tutto all’aria e lasciarsi morire – tentazione molto diffusa che si può comprendere ma pericoloso da condividere – rimboccarsi le maniche e cercare di capire insieme cosa si possa fare, dire e rappresentare per salvare il mondo dall’autodistruzione. Ho conosciuto e avuto amicizie fra i grandi registi del passato, penso a Pasolini, a Ferreri, a Pontecorvo, a Fellini, ad Antonioni, a Scola, e ritengo che abbiano molto ancora da insegnarci, non solo dal punto di vista artistico, ma nel senso di comunità che avevano, e della solidarietà che li univa quando si trattava di difendere i diritti del cinema di fronte alla cecità della politica».
MIMMO CALOPRESTI
«Perché entrare nell’ANAC ora?»
«Questo è un momento di grande trasformazione, eppure si ha un comune senso di perdita di punti fermi, anche nel cinema. Tra le piattaforme che imperversano, le sale chiuse, i set blindati, il Covid ovunque, unirsi in una realtà che fa parte dell’Italia e dei suoi autori di cinema sin dal Neorealismo, si rivela una sicurezza. Ho sposato un principio sul quale l’ANAC si sta battendo molto, in questo periodo: vedere un film al cinema, o vederlo su una piattaforma non è la stessa cosa. L’ANAC sta tentando di salvare le sale, assieme agli autori. Ma questo non significa rinnegare le piattaforme, che sono una realtà ormai consolidata. Mi sembra che, mai come in questo momento, sia necessario ribadire che il cinema esiste e che, anzi, tra le infinite proposte delle stesse piattaforme, il cinema torna al centro del mondo. Il vecchio e il nuovo: adeguarsi al nuovo mercato, pur difendendo l’identità degli autori. Non solo fare un film e farlo vedere, in un’operazione comune e complessa che si occupi di tutta la filiera del cinema, ma cercare di diffonderlo e condividerlo con il maggior numero di persone, per confronti, critiche, discussioni comuni, sempre dì più diffuse, anche grazie e attraverso la rete, che ci permette di incontrarci contemporaneamente, in uno stesso luogo, a centinaia di chilometri gli uni dagli altri, alle volte».
Cosa cerca, come autore, dentro l’ANAC?
«Il concetto di autore è largo, io sono alla ricerca di alleanze: giornalisti, scrittori, registi, per il cinema e per la cultura come centro e non come periferia, a prescindere dall’appartenenza specifica. Mi interessa molto questa fase nuova dell’ANAC perché è post ideologica. Nel senso che restano fermi i caposaldi della cultura autoriale italiana, ma ci si apre anche ad autori nuovi o inaspettati, in questa associazione. Pupi Avati, per esempio, è sempre stato considerato un individualista assoluto del cinema, e in effetti forse lo è, ma non ho mai visto tanto coinvolgimento da parte sua come in questo momento dentro l’ANAC: è molto combattivo per dare un futuro saldo al cinema. Il cinema, bisogna ricordarlo sempre, non è una forma ideologica, ma una forma di cultura, che appartiene a tutti. Attraverso il cinema, insomma, la cultura torna a essere protagonista per la collettività e per ciascuno di noi»

“Aspromonte” di Mimmo Calopresti (2019)
Quali sono le iniziative dell’ANAC in questo momento?
«Proprio in questi giorni, stiamo portando avanti la madre delle nostre battaglie per la difesa delle sale, su due fonti. Innanzi tutto, Pupi Avati, ancora una volta, ha incoraggiato i soci a intraprendere una forte pressione politica sul Ministro della Cultura Franceschini, affinché si faccia un attento e rapido piano di riapertura delle sale.
Parallelamente, ci stiamo battendo contro la chiusura delle sale cinematografiche, in questo dramma di privazioni generali dovute al virus. Mi riferisco a sale come quella grandiosa, che ha cresciuto generazioni di cinefili e cineasti: il cinema Azzurro Scipioni non deve morire. Proprio in questi giorni, noi autori dell’ANAC abbiamo chiesto ufficialmente al MIBACT e al Comune di Roma di intervenire affinché il cinema fondato da Silvano Agosti 40 anni fa, resti aperto. E, con quella sala, non deve morirne nessun’altra. Invece, lo sappiamo, succederà. Ma noi, tutti, dobbiamo opporci».
Pensa ci sia modo, attraverso l’ANAC, di portare avanti un dialogo, una collaborazione comune con le cinematografie internazionali?
«Ovviamente: la possibilità di confrontarsi anche fuori dall’Italia è al centro delle nostre necessità e dei nostri interessi. Ci sono molti temi da affrontare con il resto d’Europa, del mondo: la difesa dell’autorialità, le leggi nazionali e quelle comuni per il futuro del cinema, per rimettere il cinema al centro della politica. La piattaforma ANAC, la scuola di sceneggiatura intestata a Leo Benvenuti, il confronto con gli autori del cinema indipendente francese: sono tutte politiche di apertura, di scambio, di dialogo che ritengo indispensabili per la creatività di ciascun autore».
Da che cosa nasce l’esigenza di ricompattare l’ANAC, dopo anni di disgregazione?
«L’ANAC si è disgregata come molte realtà, negli anni scorsi, perché ognuno ha tentato di salvarsi da solo, rispetto ai propri referenti e produttori. Non illudiamoci che un autore di cinema rinneghi il proprio nome e la propria specificità. La crisi economica, dal 2008 in poi, quindi molto precedente al virus, e un degrado dovuto a politiche divulgative che hanno abbassato il livello culturale generale, un sempre maggiore deteriorarsi del senso della Politica come gestione pubblica per il bene di tutti e molti altri fattori. L’idea di battersi, mettersi davvero insieme, fa nascere la possibilità di rivendicare, difendere e creare doveri e diritti, ma anche nuove opportunità. Soprattutto in questo anno dove la pandemia ha ricreato un senso di vita, proprio perché l’ha messa in pericolo. Forse, lo spero, l’unione può aiutare a cercare soluzioni per noi stessi e per tutti quelli che lavorano con noi. Il cinema è un’arte complessa. Sono centinaia le famiglie di chi lavora nel cinema che, in questo anno, sono in gravissima difficoltà economica. L’ANAC si occuperà anche di loro perché, senza i professionisti del cinema, l’autore cinematografico non è nessuno».
Cronisti in prima linea: la nuova web series di AMD
Viaggio nell’informazione di frontiera fra antichi e recenti modelli di business criminale per conoscere chi le mafie le racconta ogni giorno
L’informazione libera è stata, è e sarà sempre il cuore pulsante del nostro Forum. Con questa nuova web serie iniziamo un viaggio attraverso i protagonisti di quell’informazione contro le mafie che quotidianamente raccontano scrivendo, filmando, registrando o postando, l’evoluzione delle mafie e il loro impatto sui territori, sull’economia, sulla società e, in ultima analisi, sulla stessa democrazia.
Sarebbe un errore appuntare l’attenzione esclusivamente sui rischi che queste/i giornalisti corrono, a volte quotidianamente, per fare il proprio lavoro, e infatti ne parleremo assai poco. Quello che ci interessa sapere dal loro privilegiato punto di osservazione è come stanno cambiando le mafie, come affrontano il dopo pandemia che è appena cominciato.
In un tempo che evidenzia la crisi strutturale dei vecchi media e non ha ancora dispiegato le potenzialità del futuro digitale, l’unico rimedio per frenare la perdita di credibilità della professione è tornare a essere giornalisti, ovvero, come diceva Albert Camus “Storici del presente”.
ENRICO FIERRO
Amalia De Simone
Francesco Vitale
“Selfie”, ovvero la fotografia della realtà
Intervista ad Agostino Ferrente, autore del documentario che ha vinto il David di Donatello. Una Napoli lontana dallo stereotipo delle serie tv si racconta in prima persona.
Un film sulle periferie della città partenopea e una scelta controcorrente: puntare su una storia di amicizia tra due ragazzi in cerca di una vita normale, piuttosto che raccontare l’ascesa epica nella criminalità organizzata. Selfie dimostra che la non violenza può essere fotogenica e sensuale
intervista di MARTA RIZZO
Selfie, il film documentario di Agostino Ferrente, per ricordare il 16enne Davide Bifolco, vince il David di Donatello 2020 come Migliore Documentario. Un racconto personalissimo, che ha il potere di scuotere nel profondo ciascuno spettatore e tutti. Davide, ucciso nel Rione Traiano perché scambiato per un latitante da un carabiniere, vive nello spazio e nel tempo filmato in video-selfie dei due sedicenni protagonisti: Alessandro e Pietro. I due amici di Davide abitano a pochi metri dal luogo della tragedia e Ferrente li trasforma in cameraman, dando loro due smartphone, per ottenere un punto di vista “immersivo”, che restituisca e faccia combaciare il loro sguardo e quello della strada, dove i ragazzi del rione trascorrono la maggior parte delle loro giornate. Ale e Pietro sono sempre presenti, protagonisti e testimoni; guidati dal regista, si specchiano nel display del cellulare, filmando e raccontando il loro ricordo. Sullo sfondo, una Napoli popolare e dimenticata, con le sue creature che crescono tra spaccio, sale giochi, carcere, sparatorie e morte; più lontano, uno Stato “latitante” che, quando c’è, spara per “errore” e uccide, di fatto, impunito. Accanto, sopra, affianco a questi diversi livelli di scrittura cinematografica, Ferrente inserisce le testimonianze di altri giovani del quartiere e le immagini delle telecamere di sicurezza poste agli angoli alti di Traiano: impassibili, inerti testimoni di giornate fatte di violenza. La rivoluzione dell’antiviolenza di due adolescenti pieni di malinconia fa il giro del mondo, nel nome di Davide.
Quelle vite raccontate attraverso uno smartphone
Come hanno vissuto questo premio i ragazzi del film?
Con emozione, incredulità e orgoglio. Alessandro l’ha saputo per ultimo, avevo provato a chiamarlo, ma aveva il telefono spento, perché già dormiva con la sveglia puntata alle 5.00 per andare ad aprire il Bar Cocco. Pietro si è commosso, lo ha dedicato a sua nonna con cui aveva girato una scena molto tenera nel film e, poche settimane dopo, è venuta a mancare. Entrambi, naturalmente, hanno pensato a Davide e tutti abbiamo ricordato come, sin dall’inizio di questa avventura, a ogni ostacolo, e ce ne sono stati tantissimi, la famiglia mi incoraggiava rievocando la vittoria di Davide contro Golia. Inevitabilmente, tutti abbiamo sorriso, pensando all’assonanza, casuale ma fatale, tra il nome di Davide e quello del prestigioso premio vinto da tutti: il David di Donatello.
Com’è cambiato il tuo pensiero su Davide, ora che tanti riconoscimenti pubblici, nazionali e internazionali, gli hanno dato quella giustizia che la Giustizia gli aveva tolto?
Come dice con amarezza la famiglia di Davide, il loro bambino è stato ammazzato 3 volte. La prima materialmente; la seconda per come la stampa ha abusato di un pregiudizio sociale, trasformando la vittima in colpevole; la terza quando la sentenza definitiva ha scagionato il carabiniere che aveva premuto il grilletto, condannandolo a una pena di soli 2 anni, sospesa da subito. Un racconto non può far tornare in vita chi non c’è più, ma ho tentato di onorare la sua memoria. Spero che il successo del nostro piccolo film, abbia potuto risanare, almeno in parte, il dolore dovuto a quella che, chi conosceva Davide, considera la sua seconda uccisione: contribuendo a ribaltare, almeno un po’, l’idea che le persone non realmente informate dei fatti, si erano fatte di questo ragazzo e dei tanti come lui. Giovani che hanno la cattiva idea di nascere in rioni popolari dove non avere diritti diventa una colpa. Ale e Pietro, raccontando la loro quotidianità, mostrano al mondo come sarebbe stata quella di Davide, se non l’avessero ucciso.
Cosa ha colpito, secondo te, i giurati David?
Non lo so, immagino che ognuno abbia avuto le sue motivazioni. Molti dei giurati, dopo averlo votato, mi hanno scritto per comunicarmi quello che avevano provato vedendo Selfie. Alcuni mi hanno detto cose somiglianti tra loro, altre molto diverse.
Qual è la rivoluzione di questo tuo film, se c’è?
Ogni opera, non solo cinematografica, dedicata a una vicenda intima, può aspirare a toccare delle corde universali. La tragedia di Davide purtroppo è una delle tante, simili, che accadono ogni giorno nel mondo. Gli abusi del potere e delle forze dell’ordine verso i più indifesi, ovvero verso le persone che dovrebbero invece proteggere, ci sono ovunque: sia nei regimi conclamati che nelle presunte democrazie. E quasi mai il potere processa sé stesso. Probabilmente anche per questo, nella vicenda raccontata da Selfie si sono identificati molti spettatori di ogni Paese: ovunque sia stato presentato mi hanno parlato di un Davide Bifolco del luogo e, per questo, il film l’ho dedicato a tutti i Davide Bifolco e tutti i rioni Traiano del mondo. Dappertutto, per esempio, in questi giorni ci sono iniziative in memoria di George Floyd, l’afroamericano soffocato dal poliziotto bianco che aveva già ucciso in passato, ed era stato già oggetto di varie inchieste. Ciononostante, era ancora in servizio. Anche da noi ci sono tantissime iniziative, di solidarietà e protesta, animate da sentimenti sinceri, senso di ingiustizia e impotenza. Eppure, in Italia, ogni “morte di Stato”, ha seguito lo stesso copione, con tentativi di insabbiamento, disinformazione della stampa (spesso complice) e assoluzione finale dei responsabili. E devo aggiungere che sui fatti italiani non c’è mai stata una simile mobilitazione.
Pensi che i ragazzi di Traiano, ora, avranno un futuro diverso?

Un’inquadratura di “Selfie”
I protagonisti di un documentario hanno la possibilità di rivedersi sullo schermo come se fosse uno specchio, relativizzando la propria vita, ragionando su loro stessi, come se si fosse fatta una lunga seduta di analisi e forse, lo spero, questo può aiutarli. Il problema è che molte questioni non dipendono da loro, ma da chi dovrebbe prendersi cura di loro. Certo, spero che un po’ questa avventura abbia potuto, nel suo piccolo, contribuire a far venire alla luce la povertà educativa, che non riguarda certo solo il Rione Traiano di Napoli. Un film non basta, può dare una scossa, ma non basta. I problemi sono atavici, endemici: il determinismo sociale, il classismo, le disuguaglianze, i pregiudizi, la mancanza di opportunità, di istruzione e lavoro.
Da dove nasce questo film e che film è?
Avevo conosciuto dalla stampa, come molti, la tragedia di Davide. Indagando meglio mi sono imbattuto in un volume dell’Edizioni dell’Asino dal titolo Una città dove ammazzano i ragazzini, nel quale compaiono due racconti di due amici che stimo moltissimo: Maurizio Braucci – lo sceneggiatore di film come Gomorra (2008) e Martin Eden (2019) – e Massimiliano Virgilio, scrittore napoletano brillante e attento. Maurizio aveva collaborato amichevolmente al mio precedente film dal vero realizzato a Napoli (Le cose belle – 2013 co-diretto con Giovanni Piperno, ndr), Massimiliano aveva scritto “cose belle” su Le cose belle… Insomma, mi fido molto del loro sguardo sulla città in cui vivono e che spesso raccontano nelle loro opere e sento di condividere con loro una stessa voglia di comprendere, attraverso l‘arte, invece di giudicare. Il volume spiega in modo chiaro come la situazione delle periferie napoletane sia frutto di un ecosistema di abbandono istituzionale. Come in tantissimi rioni popolari, le famiglie di Traiano mettono al mondo figli con un destino già scritto: se sei figlio, nipote, fratello di qualcuno che ha avuto problemi con la legge, lo sarai anche tu. Questi ragazzi sono dei predestinati. Il film racconta questo e chi cerca di non cadere nella trappola delle tentazioni direi obbligate, come Alessandro, Pietro e Davide, si ritrova ad affrontare una sfida difficile, ma non impossibile. Io faccio film “d’innamoramento”, non film “di denuncia”. Poi, se nei miei film c’è la denuncia, è una conseguenza, non l’obiettivo principale. Dal punto di vista poetico, volevo usare la metafora del come, tra le macerie, possano crescere fiori che resistono anche se nessuno li annaffia. Dal punto di vista sociale (ma i film non devono rubare il lavoro ai sociologi), volevo mostrare come in Italia ci sia ancora un forte classismo legalizzato.
Selfie non è solo un documentario, ma un esperimento di estetica dello strumento cinema e, contemporaneamente, anti-apologia, anti-stigmatizzazione sincera sulla sensualità della non violenza. La retorica dello sguardo che “una certa tendenza del cinema” italiano di denuncia (come scrive François Truffaut sullo stereotipato cinema francese tra gli anni ’50 e i primi anni ’60) sta portando avanti da troppo tempo, viene azzerata, in Selfie. Come hai costruito il film, anche grammaticalmente?
La storia di Davide, lo spunto iniziale, emerge progressivamente, dai racconti degli amici raccolti da Pietro, dalla dolorosa testimonianza raccolta da Alessandro del fratello Tommaso (poi morto anche lui, ndr) e dei genitori del ragazzo; dal sogno di Alessandro in cui la vicenda dell’omicidio dell’amico si incrocia con l’assenza del padre, in un liberatorio e asfissiante bagno al mare. Ma quella morte ha colpito l’intero quartiere, perché quello che è successo a Davide poteva succedere a qualunque altro adolescente. I livelli di sguardo si raddoppiano nei selfie delle dichiarazioni di gruppo fatte dai ragazzini del rione e nel ritorno ritmico e circolare delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Ho tentato di dare uno sguardo antieroico, come dici, affinché lo spettatore potesse partecipare il più possibile a una storia dove buoni e cattivi, giusto e ingiusto, bello e brutto non esistono. Da molti anni cerco di eliminare dal film documentario la figura dell’operatore. Dal mio Film di Mario (1999), girato a Bari, ho l’ossessione di far raccontare le storie dei miei personaggi attraverso il mezzo cinema; fino a Le Cose belle (2013), quando ho dato la telecamera a dei ragazzini per intervistare le loro mamme; la particolarità è che stavolta i ragazzini filmano se stessi e la loro “soggettiva” coincide con l’ “oggettiva”, poiché i due piani si incrociano e si fondono nello specchio del display dello smartphone. Tanto mi sembrava determinante la scelta del dispositivo, che l’ho promossa a titolo del film, pur essendo la parola in sé poco simpatica, ormai associata a un narcisismo debordante. L’intenzione era di far raccontare a Pietro e Alessandro la loro quotidianità anche per far capire come sarebbe stata quella di Davide.
Ti sei battuto contro molti pregiudizi, per realizzare questo film?
Abbastanza. Tutti noi che guardiamo, anche se in buona fede, abbiamo il filtro del pregiudizio, che è uno strumento soprattutto borghese. Quando si è diffusa la notizia dell’uccisione di Davide, la maggior parte della gente, per di più influenzata dalla stampa, ha pensato si trattasse davvero di un camorrista, e, come ricorda Alessandro nel film, ha commentato: “vabbè, uno in meno”. Ma Davide non aveva mai avuto problemi con la legge. E anche se al posto suo ci fosse stato un altro sedicenne con magari qualche conto in sospeso con la giustizia, non andava certo giustiziato seduta stante. A monte, se l’inseguimento della polizia fosse avvenuto in un quartiere bene, tipo il Vomero, il carabiniere non avrebbe sparato, credo io, pensando che quel ragazzino avrebbe potuto essere figlio di un professionista, un medico, un architetto, un avvocato… Ma questi ragazzi che fanno i militari, spesso senza un’adeguata preparazione a gestire le emergenze, sono terrorizzati a loro volta e pensano che sparare sia un modo per prevenire. Il problema non è solo il militare in questione, ma chi lo ha armato e messo lì. In USA Amnesty International (che patrocina Selfie, ndr) spiega il problema dello stigma sociale ai bambini nelle scuole con questo esempio: se vedi un bianco che corre pensi che stia cercando di non perdere il treno o di non arrivare tardi ad un appuntamento; se vedi un nero che corre pensi che stia fuggendo dopo aver commesso un qualche reato.
Alessandro, Pietro, i ragazzi del quartiere intervistati… Chi sono i veri protagonisti di questo film, a parte Davide, presente ovunque, nella sua tragica assenza?
L’espediente di dare ai ragazzi il cellulare li distrae dall’ansia da prestazione di fronte alla telecamera e li fa concentrare su ciò che devono e vogliono dire. Qualcuno equivoca pensando che il mio sia un “documentario partecipato”, ovvero uno film dove il regista consegna la telecamera ad altri che la usano autonomamente, attenendosi a delle linee guida e poi, ricevuto il girato, il regista lo monta. Nel mio caso non c’è mai una delega di regia, neanche parziale: il mio è un documentario “narrativo”, o, come lo chiamano i francesi “di creazione” e io dirigo sempre i protagonisti, che in questo caso sono, ho reso, anche cameraman. Di solito passo molto tempo con loro a telecamere spente, per raggiungere quel grado di confidenza grazie al quale, durante le riprese, non si avverta la mia presenza. E se qualcuno pensa che non c’ero, mi fa un complimento, perché vuol dire che ho raggiunto il mio scopo, dirigere restando invisibile. Certo già aver scelto quei protagonisti, è metà film: ognuno di loro, con la sua storia e faccia, i brufoli, le sue ingenuità e sogni, è portatore di un patrimonio narrativo, poi il mio lavoro di regista consiste nel trasformare le persone in personaggi e fare una sintesi poetica di pochi minuti della loro vita. Amo definirla “drammaturgia della realtà”: creare le situazioni, veicolare i tempi alla base dei dialoghi, ricordare battute utili durante le riprese, ma che magari avevano fatto prima, a telecamera spenta: metterli, insomma, diciamo così, in bella copia… Assumendomi dunque pienamente la responsabilità narrativa, poetica, estetica.
Molto interessante è il tuo approccio con i ragazzi che intervisti nel rione. In particolare, con le ragazze: chi sono quelle adolescenti con smalti psichedelici e occhi trasognati? Come hai fatto a farle sentire a loro agio, mentre le riprendevi?
Come con tutti gli altri, l’idea di chiedere anche a Sara e Antonella di auto-filmarsi è un metodo per placare un po’ l’ansia da prestazione che normalmente assale di fronte a uno strumento di ripresa. Porgendoglielo tra le mani, le ragazze si sono trovate più a loro agio, “padrone” della scena e, dunque, soggetti e non oggetti. E così si son potute aprire maggiormente, concentrandosi su quello che dicevano, dialogando tra loro. E la dichiarazione pubblica di amore eterno ai fidanzatini, che a loro dire rimarrà tale anche nel caso dovessero finire in carcere, è una cosa che considero romantica. Ma è pur sempre una promessa d’amore di ragazzine di 16 anni, perché quando si è innamorati pensiamo e vogliamo che sia per sempre. Magari poi le cose cambiano, e a quell’età cambiano velocemente, quindi non scomodiamo subito l’idea di un assoggettamento cieco e rassegnato a un’arcaica e maschilista cultura dell’appartenenza. Mi spiego: cosa c’è di più importante e valoroso della vita e della libertà? Le ragazze del Rione, s’innamorano di ragazzini della loro età, che, dai 12 anni in su, stanno tutto il giorno sui motorini, nelle sale da gioco, e talvolta finiscono, ancora bambini, in giri più grandi di loro e sanno che o andranno in carcere, o moriranno ammazzati. Così, come loro sembrano pronti a sacrificare la libertà o esistenza, allo stesso modo le fidanzatine, contraccambiano dicendosi pronte a sacrificare la loro libertà sentimentale, promettendogli fedeltà per la vita… Insomma, anche in questo, il determinismo sociale, l’emarginazione, non fanno distinzione tra maschi e femmine: è una fetta cospicua di società viene messa al margine. Il determinismo sociale travalica sessi e ruoli: quelli che finiscono per spacciare stanno a Traiano, quelli che consumano, studenti e professionisti, stanno lì vicino, al Vomero: due mondi che sono due facce della stessa medaglia, che si alimentano a vicenda e si completano. Chi paga, però, sono solamente i ragazzini che spacciano.
Quale differenze hai voluto sottolineare, tra la vita di una periferia del sud, di Napoli, e la vita di spettatori lontani, spesso del tutto inconsapevoli di un mondo quotidianamente al limite tra legalità e illegalità?
La distinzione tra lavoro onesto e disonesto la possiamo fare noi dal di fuori. I ragazzi dei quartieri, come di tante città italiane, ti dicono che se nascono con un padre che spaccia, perché loro non dovrebbero farlo? Come dicevo, la distinzione netta tra bene e male è un concetto molto borghese, teorico: lì ci sono ragazzi che non hanno nessun filtro per distinguere e nella stessa comitiva c’è il ragazzino che ti dice: “Mio padre fa il carrozziere, mio padre il barbiere e mio padre spaccia”. Non sono certo un sindacalista della criminalità, ma guardo ragazzini che stanno 8 ore a spacciare per 80 euro al giorno, senza contributi, tutt’ al più vanno in galera, o muoiono. Di certo i genitori avrebbero preferito un altro lavoro per loro. Ma spesso il “crimine” diventa una conseguenza naturale, non una scelta ponderata e questo meccanismo andrebbe interrotto, cambiando le condizioni che lo provocano. E certo non può farlo un documentario.
Alessandro e Pietro come vivono il loro essere abitanti di Traiano?
Cercando di opporsi ad un destino che sembra essergli stato cucito addosso appena nati. Come dicevo, non è facile, ma neanche impossibile. Loro ci provano, vanno aiutati, supportati, incoraggiati e non guardati con sospetto appena la gente viene a sapere da dove vengono.
Chiudiamo con una cosa bella, oltre il dolore del film. Decidi tu come concludere.
Vorrei ricordare l’Associazione nata in memoria di Davide (Associazione Davide Bifolco Onlus), che si occupa di fare doposcuola volontaristicamente con ragazzi che altrimenti si perderebbero per strada. Di fatto fanno, come possono, quello che dovrebbero fare le istituzioni, che neanche la sostengono. E quando dici istituzione, in posti come il Rione Traiano, subito pensano alle camionette delle forze dell’ordine.
Auser e AMD insieme per i diritti
Quella fra Auser e l’associazione “A mano disarmata” è una collaborazione che nasce sotto il segno della cittadinanza attiva: da una parte una grande associazione radicata sul territorio e attiva su molti fronti, dall’altra un gruppo di professionisti dell’informazione e della formazione che lavora sui temi della lotta alle mafie.
La legalità, il rispetto delle regole, la promozione dei diritti del cittadino e la difesa della democrazia sono gli assi portanti di questa collaborazione che prende avvio su un tema di grande attualità: i pericoli nei quali si può incorrere nell’utilizzo di internet.
Non è che l’inizio di un cammino collettivo nel quale svilupperemo, di comune accordo con le articolazioni di Auser a tutti i livelli, un lavoro di approfondimento delle conoscenze attraverso iniziative, seminari e quant’altro potremo mettere in campo.
La democrazia è un bene fragile, sottoposto a stress continui: dalle disuguaglianze sociali ai gap di competenze, dai ritorni di fiamma per soluzioni autoritarie a minacce che non è facile identificare.
Intervista al Presidente Vincenzo Costa
Le mafie, per esempio, sono un fenomeno in costante espansione e, come segnalano gli investigatori della Procura Nazionale Antimafia, sono pronte ad approfittare dei momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo, per rafforzare la loro potenza economica e consolidare il dominio criminale. Il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine va affiancato dalla vigilanza dei cittadini e dalla crescita della cultura della legalità. Ed è qui che Auser e “A mano disarmata” possono dare il loro contributo.