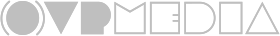Nonostante arresti e condanne, le mafie (purtroppo) stanno benissimo. La ‘ndrangheta soprattutto. È questo il quadro – amaro – tracciato dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna) presentata oggi al Senato dal Procuratore nazionale Franco Roberti e dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi nella relazione con cui annualmente fa il punto sulle attività svolte dalle diverse Dda durante l’anno. Il 2016 – emerge dal documento – è stato un anno di successi, investigativi e processuali, ma le mafie storiche non sono in crisi. Al massimo, stanno cambiando pelle e strategia per meglio adattarsi ai vuoti provocati da arresti e condanne e alle modificazioni del mercato. Fatta eccezione per Napoli città, dove il periodo di fibrillazione dovuto ad arresti e condanne di capi storici ha dato la stura a un aumento della violenza sanguinaria dei clan, oggi guidati da giovanissimi e incontrollabili leader, le mafie sembrano aver optato per una strategia di controllo del territorio diversa ma altrettanto efficace.
MAFIE COME AUTORITA’ PUBBLICHE
Le mafie stesse rischiano di diventare ‘autorità pubblica’ in grado di governare processi e sorti dell’economia. “L’uso stabile e continuo del metodo corruttivo-collusivo da parte delle associazioni mafiose determina di fatto l’acquisizione (ma forse sarebbe meglio dire, l’acquisto) in capo alle mafie stesse, dei poteri dell’autorità pubblica che governa il settore amministrativo ed economico che viene infiltrato”, si legge nella relazione.
“Acquistato, dal sodalizio mafioso, con il metodo corruttivo collusivo, il potere pubblico – si legge nel testo – che viene in rilievo e sovraintende al settore economico di cui si è intenso acquisire il controllo, questo viene, poi, illegalmente, meglio, criminalmente, utilizzato al fine esclusivo di avvantaggiare alcuni (le imprese mafiose e quelle a loro consociate) e danneggiare gli altri (le imprese e i soggetti non allineati)”.
MAFIE IN GRADO DI INDIRIZZARE INVESTIMENTI PUBBLICI
“Assai spesso, è la stessa organizzazione mafiosa che, avendo acquisito le necessarie capacità tecniche e le indispensabili relazioni politiche, individua essa stessa il settore nel quale vi è possibilità di ottenere finanziamenti e, quindi, conseguenzialmente, indirizza ed impegna la spesa pubblica. Si tratta del vulnus più grave alla stessa idea, allo stesso concetto di autonomia locale”. E’ questa la novità introdotta dalla criminalità che vuole aggiudicarsi gare e appalti pubblici, utilizzando la corruzione. Non più soltanto tangenti per entrare nella partita, ma intervento diretto nella elaborazione della stessa attività di ideazione, gestione e realizzazione dei bandi di gara.
“Individuati i fondi necessari, pagato o promesso il corrispettivo al politico che ha dato il via libera e attribuito il finanziamento all’ente locale, chiude il primo passaggio, il primo step, e l’opera può essere messa a gara”, scrive Roberti, sottolineando come “l’impresa del cartello o un professionista incaricato, redige integralmente il bando di gara e lo consegna agli uffici amministrativi pubblici spesso neppure attrezzati tecnicamente a redigerlo”.
“Bandita la gara, si innesta l’attività corruttiva-collusiva tesa a fare coincidere il nome del vincitore con quello della ditta del cartello che aveva prima fatto finanziare l’opera e, poi, aveva impostato il bando di gara (al fine di aggiudicarsela)”, conclude la Direzione nazionale antimafia.
NIENTE (O POCO) SANGUE, MEGLIO LA CORRUZIONE
Il metodo “collusivo-corruttivo” ha progressivamente sostituito omicidi, azioni di fuoco e violenza, sempre più relegate al rango di estrema ratio, ma tanto presenti nella memoria collettiva da avere tuttora valenza intimidatoria. Traduzione, ai clan non serve sparare, anzi non lo ritengono conveniente perché attira attenzione e sottrae consenso sociale, dunque corrompono, comprano, coinvolgono professionisti, pubblici ufficiali e politici anche grazie alla forza di intimidazione che deriva dalla memoria del sangue versato. “Le mafie – si legge infatti nella relazione della Dna – anche senza l’uso di quelle che si riteneva fossero le loro armi principali, continuavano e continuano, non solo, a raggiungere i loro scopi di governo del territorio, di acquisizione di pubblici servizi, appalti, interi comparti economici, ma continuano a farlo avvalendosi dell’assoggettamento del prossimo (sia esso un imprenditore concorrente o un qualsiasi altro cittadino) riuscendo a porre costui, senza fare ricorso all’uso della tipica violenza mafiosa, in uno stato di paralizzata rassegnazione, nella quale, in sostanza, è in balia del volere mafioso”. Obiettivo? Quello di sempre, il profitto. Che negli anni della crisi sono soprattutto gli appalti pubblici ad assicurare. E le mafie, la ‘ndrangheta in particolare, sono capaci di accaparrarsi su tutto il territorio nazionale, anche grazie al coordinamento della “direzione strategica”, individuata quest’anno grazie alle indagini della Dda di Reggio Calabria.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL 416 BIS
Ecco perché la Dna torna a sollecitare – per il secondo anno consecutivo – una modifica del 416 bis, l’articolo del codice penale che disciplina il reato di associazione mafiosa, che permetta agli inquirenti di colpire i clan in questa loro nuova veste, aggravando di un terzo la pena “se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo (..) sono acquisite, anche non esclusivamente, con il ricorso alla corruzione o alla collusione con pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio, ovvero ancora, con analoghe condotte tese al condizionamento delle loro nomine”. Al netto dei differenti stadi evolutivi che mafia siciliana, ‘ndrangheta e camorra stanno attraversando, emerge infatti un tratto comune che la Dna non esita ad identificare in “un inarrestabile processo di trasformazione delle organizzazioni mafiose, da associazioni eminentemente militari e violente, ad entità affaristiche fondate su di un sostrato miliare”. Per questo “gli omicidi ascrivibili alle dinamiche delle organizzazioni mafiose sono complessivamente in calo, mentre il panorama delle indagini mostra un forte dinamismo dei sodalizi in tutti gli ambiti imprenditoriali nei quali viene in rilievo un rapporto con la pubblica amministrazione”.
L’ECCEZIONE NAPOLI E LA FEROCIA DEI BABY CAMORRISTI
A Napoli si spara ancora, ma è un’eccezione rispetto al generale trend della camorra e delle mafie storiche tutte. A differenza di tutti gli altri territori, nel capoluogo napoletano si registra un aumento degli omicidi di chiara matrice camorristica, che nel corso del 2016 passano da 45 a 65. A firmarli – spiega la Dna – sono “killer giovanissimi che si caratterizzano per la particolare ferocia che esprimono ed agiscono al di fuori di ogni regola” ed agiscono in esecuzione delle direttive di “quadri dirigenti che fino a pochi anni fa non erano in prima linea”. Arresti e condanne dei capi storici hanno aperto vuoti di potere che “nuove leve criminali che scontano inevitabilmente una non ancora compiuta formazione strategica” pretendono di colmare. Il risultato è “un quadro d’insieme caratterizzato dall’esistenza di molteplici focolai di violenza”. E in questo contesto – evidenzia con preoccupazione la Dna- “i quartieri del centro storico che da sempre hanno suscitato i voraci appetiti della criminalità organizzata, in ragione dell’esistenza di fiorenti mercati della droga, delle estorsioni e della contraffazione, hanno rappresentato e rappresentano tuttora la vera emergenza criminale per il distretto di Napoli”.
CAMORRA
Radicalmente diversa e assolutamente in linea con il trend nazionale è invece la situazione nelle aree storicamente controllate dai casalesi e dagli altri clan attivi nel casertano, a nord di Napoli e nel beneventano. In queste zone non si spara più. Ma – si legge nella relazione – “il fatto che in Provincia di Caserta il numero di omicidi commessi al fine di agevolare organizzazioni mafiose, sia pari a quello che si registra, ad esempio, in provincia di Cuneo o Bolzano, cioè zero, non significa affatto che sia riscontrabile un livello ed una presenza della criminalità di tipo mafioso comparabile a quella riscontrabile nelle due province citate a titolo di mero esempio”. Piuttosto, è la manifestazione di una nuova strategia di lungo respiro, basata sull’infiltrazione negli appalti e nei pubblici servizi, “sempre più agevolata da collegamenti stretti con la politica e l’imprenditoria”, piuttosto che sul ricorso alla violenza.
I NUOVI CAPI SONO IMPRENDITORI-MAFIOSI
Una trasformazione in linea con il profondo cambiamento della composizione dei vertici delle diverse organizzazioni camorriste, oggi guidate da quegli “imprenditori-camorristi” che in passato erano uomini di fiducia dei capi militari ed oggi si ritrovano al vertice delle varie organizzazioni. Sono uomini d’affari, non generali. Per questo, “pur mantenendo sullo sfondo la possibilità del ricorso alla violenza, che rimane il sostrato su cui si fonda una intimidazione immanente e perdurante”, la loro strategia è “la via negoziale (quasi sempre illecita), che, altro non è che estrinsecazione del metodo collusivo-corruttivo ad ogni livello”.
COSA NOSTRA SICILIANA
Non sfugge al medesimo trend la mafia siciliana, che al pari se non più della camorra, si è dimostrata in grado non solo di rimanere presente su tutto il territorio regionale, ma è stata soprattutto capace di mettere in atto una “permanente e molto attiva opera di infiltrazione, in ogni settore dell’attività economica e finanziaria, che consenta il fruttuoso reinvestimento dei proventi illeciti, oltre che nei meccanismi di funzionamento della Pubblica Amministrazione, in particolare nell’ambito degli Enti Locali”. Insomma, i clan siciliani non sparano ma ci sono e sanno infettare la “Cosa pubblica”. Dopo gli anni della strategia di “sommersione” seguita alla cattura di Bernardo Provenzano, Cosa nostra sta attraversando una nuova fase – di transizione – tesa all’individuazione di una nuova leadership, ma questo non ha dato la stura ad un conflitto violento fra famiglie. Il tessuto di regole consolidato nei decenni passati – la cosiddetta “costituzione formale” – ha permesso all’organizzazione di “risollevarsi dalle ceneri”. “Cosa Nostra – spiega infatti la Dna – si presenta tuttora come un’organizzazione solida, fortemente strutturata nel territorio, riconosciuta per autorevolezza da vasti strati della popolazione, dotata ancora di risorse economiche sconfinate ed intatte e dunque più che mai in grado di esercitare un forte controllo sociale ed una presenza diffusa e pervasiva”.
MODIFICA NORMATIVA PER COLPIRE I RECIDIVI
A guidare i clan – segnala con allarme la Dna – ci sono spesso storici esponenti dell’organizzazione, che finita di scontare la pena tornano alle vecchie attività. Per questo dal gruppo di magistrati che in Dna si occupa di Sicilia arriva un’ulteriore proposta di modifica del 416 bis che preveda “un meccanismo sanzionatorio particolarmente rigoroso per escludere per un non breve periodo di tempo dal circuito criminale quegli appartenenti all’organizzazione mafiosa che dopo una prima condanna, tornino a delinquere reiterando in tal modo la capacità criminale propria e dell’organizzazione”.
RISVEGLIO DELLA SOCIETA’ CIVILE
Dalla Sicilia arrivano però anche segnali positivi. Soprattutto a Palermo, sottolineano dalla Dna, l’efficace azione di contrasto, unita “all’obbiettiva minore autorevolezza ed al minore prestigio degli esponenti mafiosi, determina condizioni favorevoli affinché il consenso, l’acquiescenza o quanto meno la sudditanza di cui l’organizzazione ha goduto in passato e che già ha perso in parte degli ambienti sociali, in particolare del capoluogo, vengano definitivamente a mancare”. E forse non a caso, a fronte di un numero delle estorsioni sostanzialmente costante, sono aumentate esponenzialmente le denunce.
‘NDRANGHETA
Nessun segnale di questo genere si registra invece nelle terre dominate dalla ‘ndrangheta, tra le mafie storiche di certo quella più in salute. “Si è di fronte ad un complesso di emergenze significative, ancora di più che in passato, di una ndrangheta presente in tutti i settori nevralgici della politica, dell’amministrazione pubblica e dell’economia, creando – constata la Dna – in tal modo, le condizioni per un arricchimento, non più solo attraverso le tradizionali attività illecite del traffico internazionale di stupefacenti e delle estorsioni, ma anche intercettando, attraverso prestanome o, comunque, imprenditori di riferimento, importanti flussi economici pubblici ad ogni livello, comunale, regionale, statale ed europeo”. E non solo in Calabria.
LA COLONIZZAZIONE DEL NORD
I clan non solo si confermano capillarmente presenti su tutto il territorio calabrese, ma giorno dopo giorno si dimostrano in grado di infettare sempre più territori diversi. Traduzione, il contrasto alla ‘ndrangheta non è un problema della Calabria, ma nazionale se non internazionale. Nelle diverse regioni del Nord Italia i clan hanno messo radici solide. Se il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Toscana sono per la Dna territori di reinvestimento grazie a operatori economici compiacenti, Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna ed Umbria, sono invece regioni in cui “vari sodalizi di ndrangheta hanno ormai realizzato una presenza stabile e preponderante”. Un’infezione che ha contaminato i territori non grazie al sangue versato, ma utilizzando “il “capitale sociale”, fatto di relazioni con il mondo politico, imprenditoriale ed economico”.
ALLARME GRANDI OPERE
E soprattutto al Nord c’è un dato che a detta della Dna desta “particolare preoccupazione”: l’attivismo dei vari sodalizi di ndrangheta “nel tentativo di inserirsi – attraverso imprese proprie o, comunque, di riferimento – nei procedimenti aventi ad oggetto la realizzazione delle “grandi opere”, tra cui, in passato, i lavori legati ad Expo 2015, ed oggi la Tav, nella tratta Torino-Lione, nonché la capacità dagli stessi dimostrata, di fare dei più importanti scali portuali del nord – Genova, Savona, Venezia, Trieste, Livorno – degli stabili punti di sbarco dei grossi quantitativi di sostanza stupefacente importata dal sud-America, in aggiunta a quello di Gioia Tauro”. E se un tempo i “camalli” e le loro organizzazioni sindacali erano argine naturale all’infiltrazione della criminalità organizzata, oggi – si legge nella relazione – sono in tanti ad essere al servizio dei clan e questo – constata la Dna – è “espressione e misura del grado di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nei gangli vitali della società”.
MINACCIA EVERSIVA
In ragione della sua capacità di contaminazione, la ‘ndrangheta – emerge dalla relazione – è dunque una minaccia per la stessa democrazia. Un dato che diventa ancor più preoccupante ed attuale alla luce del nuovo organismo scoperto dai magistrati di Reggio Calabria. Le indagini del 2016 hanno infatti permesso di individuare la direzione strategica della ‘ndrangheta e alcuni dei suoi componenti. Non si tratta di capi militari ma di professionisti, pubblici funzionari, deputati e senatori. Per i magistrati di Reggio Calabria nella cabina di comando della ‘ndrangheta hanno funzione apicale un ex deputato della Repubblica, Paolo Romeo, massone e vincolato da legami storici e consolidati alla destra eversiva e un avvocato ed ex consigliere comunale, Giorgio De Stefano, legato per sangue e ruolo ad uno dei clan più potenti della ‘ndrangheta tutta. Attorno a loro gravitano un importante dirigente della Regione Calabria, Franco Chirico, un ex sottosegretario regionale, Alberto Sarra, e persino un senatore della Repubblica, Antonio Caridi, arrestato quando ancora sedeva in Parlamento.
DEMOCRAZIA SCIPPATA
È questo nucleo ad aver deciso tutte le elezioni che si siano svolte in Calabria dal 2001 a – quanto meno – il 2012. Non si tratta – ed è questo il dato nuovo – dell’ormai canonica raccolta di voti per questo o quel candidato, ma di una pianificazione previa degli uomini e degli schieramenti migliori per garantire all’organizzazione appalti, lavori, commesse, scelte politiche e strategiche. Al momento, secondo quanto emerso dalle indagini, la Santa – questo il nome del nuovo organismo è in grado di determinare le macropolitiche criminali di tutto il mandamento reggino. Ma più di un elemento, proveniente da vari territori, sembra far emergere una tendenza al coordinamento al vertice di organizzazioni criminali diverse ma unite da un comune obiettivo, il profitto.
di ALESSIA CANDITO
(La Repubblica.it 22 giugno 2017)